|
O. R. I. Organizzazione per la Resistenza Italiana
di Enzo Casadio e Massimo Valli
L' 8 settembre del 1943, a seguito della
comunicazione dell'armistizio che l 'Italia aveva firmato con gli Alleati, vi
fu lo sbandamento delle forze armate, che erano state lasciate senza
disposizioni precise. Molti reparti si sciolsero e i militari tentarono di
raggiungere i loro luoghi di origine; altri rimasero sufficientemente compatti
ed iniziarono ad operare a fianco degli Alleati, contro le forze tedesche.
L'esercito tedesco disarmò e deportò nei campi di lavoro in Germania alcune
centinaia di migliaia di militari italiani. Vi furono anche numerosi tentativi
di resistenza alle truppe germaniche, seppure isolati e non coordinati, come la
cosiddetta "difesa di Roma" e gli avvenimenti nelle isole dell'Egeo
che portarono a gravi rappresaglie.
Apparecchiatura radio 3 MK II,
simile a quella utilizzata dai gruppi dell'ORI.
|
In quei giorni, nell'Italia meridionale liberata
dagli anglo americani, si viveva un notevole fermento. II Governo, che si
era stabilito a Brindisi, e le alte sfere militari, cercavano di costituire
reparti combattenti italiani per guadagnare credibilità di fronte agli Alleati.
Ma le cose andavano a rilento a causa delle reciproche diffidenze tra gli
italiani e gli Alleati. Gli anglo americani preferivano utilizzare i militari
italiani come forza lavoro per i servizi e non sembravano intenzionati ad
utilizzarli come combattenti. Al Sud affluirono anche numerosi volontari che
intendevano partecipare alla guerra per la liberazione nazionale. Mentre
fervevano i contatti per la costituzione di reparti militari italiani, i
servizi di informazione anglo americani intensificarono la loro attività, sia
per raccogliere informazioni di tipo militare, sia per contribuire a formare un
gruppo dirigente di personalità italiane di provata fede antifascista che
potessero dare una guida politica al Paese e contribuire cosi alla ripresa
della vita democratica. Furono presi contatti con numerose personalità della
politica e della cultura e furono fatti rientrare in Italia alcuni esponenti
antifascisti. Gli inglesi impiegavano in Italia il SOE (Special Operation
Executive). Gli americani utilizzavano una struttura denominata OSS (Office of
Strategic Services). Mentre gli inglesi operavano già da tempo nel nostro Paese,
l'OSS americano era di più recente costituzione ed aveva pochi contatti con i
vertici politici e militari italiani e con i fuoriusciti antifascisti.
|
Gli
inglesi, sostanzialmente, lavoravano per mantenere sul trono il re e per
utilizzare la classe dirigente del momento, opportunamente trasformata. Gli
americani operavano per un cambiamento più radicale e cercavano di individuare
tra i gruppi di antifascisti persone che potessero influenzare l'opinione
pubblica dell'Italia liberata e che rappresentassero dei punti di riferimento
per chi nel Centro Nord era ancora sotto l'occupazione tedesca. II SOE inglese
aveva quindi dei buoni contatti il governo italiano, che si trovava a Brindisi,
e con il SIM, il servizio di informazione militare italiano, che disponeva di
molti uomini che operavano al Nord. Dopo
l'attacco a Pearl Harbor, gli Stati Uniti avevano compreso la necessità di
avere un adeguato servizio di informazione specializzato nello spionaggio e nel
sabotaggio.
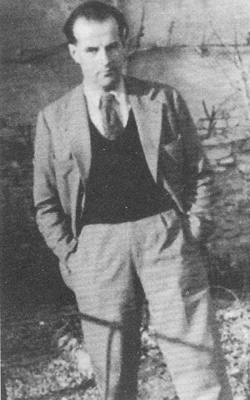
Raimondo Craveri (Mondo)
L'ideatore dell'ORI a Napoli nel 1943.
|
Questo
portò, nel giugno del 1942, alla nascita dell’OSS. A capo della sezione
italiana era un giovane ufficiale di origine italiana, Massimo (Max) Corvo, che
provvide a reclutare altri oriundi italiani, tra i quali Vincent Scamporinoi,
un giovane avvocato di origine siciliana, che divenne il vice responsabile per
le operazioni nell’area del mediterraneo. Vi furono sempre delle difficoltà nei
rapporti tra i due servizi alleati. Nei primi giorni di settembre del 1943,
sulla costiera amalfitana, avvenne l’incontro tra l’avvocato piemontese
Raimondo Craveri e gli uomini dell’OSS. Craveri, che aveva sposato la figlia di
Benedetto Croce, era stato uno dei fondatori del Partito d’Azione e stava
cercando di prendere contatto con gli Alleati per illustrare la situazione
politica nella capitale e per contribuire alla guerra di liberazione. Tra Craveri e l'agente americano Peter
Tompkins, un giovane giornalista americano del New York Herald Tribune, che
conosceva bene le vicende politiche italiane, nacque subito una notevole
simpatia, che facilitò il lavoro che dovevano compiere. L'idea che circolava in
quei giorni era di costituire il Corpo Volontari Italiani, affidandone il
comando al generale Pavone, ma il progetto non decollò per le incomprensioni
con gli alti vertici militari italiani. Questo progetto fu successivamente
modificato e portò alla costituzione del Primo Raggruppamento Motorizzato, il
primo reparto militare italiano che iniziò a combattere a fianco degli Alleati
contro i tedeschi. L'intraprendenza di Craveri, che cercava di creare una
struttura che potesse operare subito per la liberazione del Paese, portò
all'idea di costituire gruppi di volontari italiani, che, opportunamente
addestrati, potessero essere inviati nell'Italia occupata per raccogliere
informazioni militari e politiche, ricevendo in cambio rifornimenti di armi e
materiali per i reparti partigiani. Attorno
alla figura carismatica di Craveri si stava raccogliendo un gruppo di giovani
antifascisti disposti a partecipare a questo tipo di operazioni. Tra di loro
c'erano alcuni antifascisti romagnoli, prevalentemente di ispirazione
repubblicana e azionista, che, dopo l'8 settembre, avevano deciso di raggiungere
l'Italia meridionale per contribuire fattivamente alla liberazione del Paese.
|
Partiti in bicicletta diretti verso il Sud e attraversate le linee tedesche nei
pressi di Termoli, avevano raggiunto la Puglia e, successivamente, Napoli.
Delusi dal fallimento dei tentativi di ricostituzione di reparti combattenti
italiani sotto il controllo della vecchia gerarchia militare, incontrarono il
gruppo di Craveri e decisero di collaborare al progetto di costituzione
dell'ORI. L'ORI (Organizzazione per la Resistenza Italiana) nacque
ufficialmente il 15 novembre 1943, quando i 37 volontari che la fondarono ne
sottoscrissero lo statuto. L'addestramento iniziò subito nella villa di
Pozzuoli, dove aveva sede l’ORI, e in Algeria. Gli uomini furono addestrati
alle tecniche di sabotaggio, all'uso di apparecchiature radiotelegrafiche, alla
raccolta e gestione delle informazioni e al lancio con il paracadute. Le
operazioni dovevano avvenire con gruppi di tre o quattro uomini che dovevano
essere infiltrati oltre le linee tedesche o tramite lancio col paracadute o
sbarco da sommergibili. Ogni gruppo disponeva di una radio ricetrasmittente per
mantenere i contatti con la base dell' OSS.
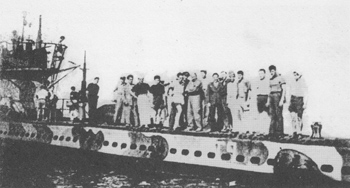
Gli operatori dell'Ori con alcuni membri
dell'equipaggio sul sommergibile Platino.
|
Alla
fine di gennaio del 1944, alcuni gruppi erano pronti ad operare. La prima
partenza avvenne il 17 febbraio, quando tre team furono portati a Brindisi e
imbarcati sul sommergibile Platino. Due gruppi dovevano essere sbarcati in
Romagna per operare nella zona Ferrara — Ravenna - Rimini e nell'Appennino
romagnolo, un terzo gruppo doveva essere sbarcato alla foce del Brenta per
operare in Veneto. I nomi in codice dei gruppi erano "Elvira",
"Zella", "Bianchi". II
gruppo "Elvira" era formato dai ravennati Matteo Savelli (Arcangeli),
Giorgio Roncucci e dal radiotelegrafista Luigi Cima. "Zella" era
costituito da Antonio Farneti (Roberti) e Celso Minardi, ambedue ravennati, e
dal radiotelegrafista sardo Andrea Grimaldi (Zanco).II team
"Bianchi" era composto da Bianchi, dal faentino Domenico Montevecchi
(Musmeci) e dal radiotelegrafista Mario. Questa squadra doveva essere sbarcata
per prima, alla foce del Brenta, ma, a causa del cattivo tempo, si preferì
effettuare lo sbarco in una zona più riparata nei pressi di Parenzo in Istria.
Mentre il gruppo cercava di raggiungere la zona di operazioni che gli era stata
assegnata, fu catturato dai tedeschi. |
Gli uomini furono imprigionati a Verona e
torturati perché rivelassero gli scopi della loro missione. Bianchi si suicido
e Montevecchi fu fucilato a Bolzano il 12 settembre 1944. I due gruppi diretti
in Romagna dovevano essere sbarcati nella zona di Porto Garibaldi, ma, per un
errore del comandante del sommergibile, furono sbarcati circa 15 chilometri più
a nord. Credendo di essere arrivati a terra, Farneti e i suoi uomini avevano
tagliato il canotto per nasconderlo meglio. Solo dopo si resero conto di non
essere sbarcati sulla terraferma ma su un banco di sabbia. Per loro fortuna
sbarcò li anche il gruppo di Arcangeli, cosi poterono utilizzare il loro
canotto per raggiungere la riva. La cosa fu molto difficile in quanto il
piccolo canotto non era adatto a portare sei uomini, due valige con le radio e
i bagagli. Bagnati e intirizziti dal freddo raggiunsero un casa di contadini,
dove ottennero accoglienza spacciandosi per militari italiani fuggiti dalla
Jugoslavia. Parlando con gli abitanti della casa, si accorsero di non essere
stati sbarcati nella zona di Porto Garibaldi, ma alle foci del Po di Goro.
Ritenendo che fosse molto pericoloso raggiungere Ravenna via terra, dopo alcuni
giorni si fecero accompagnare da un pescatore con una barca e, dopo avere
risalito il fiume Reno, raggiunsero una fattoria nella pineta ravennate. I due
gruppi si divisero. Il team guidato da Arcangeli ebbe problemi con la radio,
che non entrò mai in funzione e fu trovata dopo una decina di giorni dai
tedeschi durante un rastrellamento. II team "Zella", guidato in
maniera determinata da Farneti, ebbe miglior sorte. Farneti, arrivato a
Ravenna, prese contato con gli antifascisti locali, in particolare i repubblicani
che conosceva meglio e che lo aiutarono a nascondere la radio.
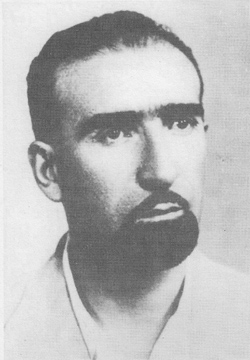 |
Il notaio Virgilio Neri (1906-1982), che ospitò nella sua
villa la radio e il radiotelegrafista, colloborando
attivamente con Farneti nella raccolta delle
informazioni e nel tenere i contatti con la resistenza locale.
Bruno Neri (1910-1944), famoso calciatore della Fiorentina, della Lucchese, del Torino e della Nazionale, collaborò
attivamente con il cugino Virgilio a sopportare la missione "Zella".
Nominato vice comandante del Battaglione Ravenna, cadde in
uno scontro con i tedeschi nei pressi di Gamogna il 10 luglio 1944.
|
 |
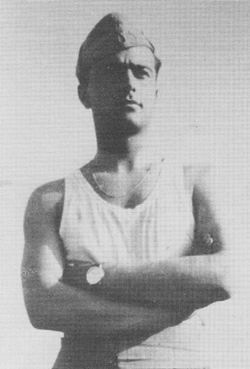
Virgilio Bellenghi (1916-1944),
ufficiale dell'Esercito,
aderì all'ORI e nel Luglio del 1944 divenne
comandante del Battaglione Ravenna.
Cadde a Gamogna unitamente a Bruno Neri.
|
L'8 marzo 1944
Farneti, aiutato da un dirigente repubblicano, Laudon Gaudenzi, trasferì la
radio a Lugo presso la casa di Enrico Blosi. Poi, presso la casa di Luigi Poggiali
sotto l'argine del Senio, il giorno 19 fu trasmesso il primo messaggio. In
quei giorni Farneti incontrò il notaio faentino Virgilio Neri e suo cugino, Bruno
Neri. Con loro studiò un piano per riorganizzare le bande partigiane che
operavano nella zona e per creare una rete di raccolta di informazioni sulle
fortificazioni e sui movimenti delle truppe tedesche da trasmettere al comando
dell'OSS. Da
Lugo, il 16 aprile, la radio fu trasportata nella villa del notaio Neri a
Rivalta, sulla via che da Faenza porta a Modigliana. Sistemata nella chiesetta
della villa, la radio operò quasi quotidianamente. Tramite le conoscenze del
dott. Neri, che aveva costituito una rete di informatori in tutto il nord
Italia, furono raccolte importanti notizie che venivano subito trasmesse al
Sud. A Faenza Farneti incontrò Vittorio Bellenghi, Vincenzo Lega e Tonino
Spazzoli. Tramite quest'ultimo venne in contatto con un gruppo di ufficiali
inglesi, tra cui cinque generali, che, prigionieri di guerra in Italia, erano
fuggiti dopo l’8 settembre e, dopo una serie di spostamenti, erano giunti
sull'Appennino forlivese, dove, assistiti dai partigiani locali, cercavano il
modo per raggiungere il Sud. Grazie ai contatti tenuti con la radio, fu
possibile organizzare l'evacuazione via mare del gruppo di ufficiali inglesi. La
struttura che ruotava attorno a radio Zella era composta da Antonio Farneti,
Virgilio Neri, Bruno Neri, Vittorio Bellenghi, Tonino Spazzoli,Vincenzo Lega e
Claudio Silimbani. Spazzoli, Silimbani e Lega si occupavano della raccolta
delle informazioni e dei collegamenti; Virgilio e Bruno Neri e Vittorio
Bellenghi si occupavano dell'organizzazione delle bande e della gestione degli
aviolanci. Per potere dare una maggiore consistenza alle bande di partigiane
che agivano sull'Appenino faentino era indispensabile fare arrivare
rifornimenti di armi e materiali. Fu cosi organizzato un aviolancio che doveva
avere luogo alla fine di maggio del 1944, nella zona del monte Faggiola, dove
operava una formazione partigiana della Brigata Garibaldi. Tramite la radio fu
richiesto l’aviolancio. Poiché nei giorni indicati la zona del Faggiola era
sottoposta ad un rastrellamento da parte dei tedeschi, si decise di effettuarlo
in un'altra zona. |
Fu scelta quindi la zona del monte Castellaccio nei pressi
della Pietramora a sud di Faenza. Le armi sarebbero state distribuite tra tutti
i Comitati di Liberazione che prendevano parte alla raccolta. Dopo alcuni
giorni di attesa e alcuni tentativi andati a vuoto, il 10 giugno Radio Londra
trasmise il messaggio in codice che i partigiani attendevano: "La bambola
dorme", che significava che nella notte sarebbe avvenuto l’aviolancio. I
partigiani si portarono nella zona stabilita e si prepararono ad accendere le
segnalazioni luminose per indicare all'equipaggio dell'aereo la zona precisa di
lancio. Poco prima della mezzanotte un aereo passò molto basso sul punto
previsto, ripassando poi successivamente. A questo punto furono accesi i
segnali e l'aereo effettuò 8 passaggi lanciando una quarantina di paracadute.
Furono lanciati circa 25 quintali di materiali: mitra, mitragliatrici, bombe a
mano, munizioni, esplosivo, indumenti e anche 500.000 lire.
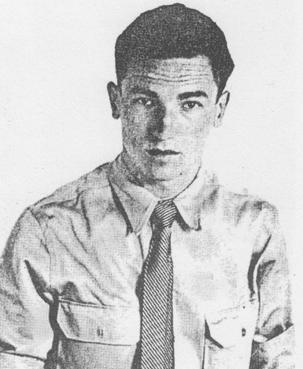
Antonio Farneti, capo team
della missione "Zella".
|
Il materiale
raccolto fu nascosto e distribuito nei giorni successivi. Il successo dell’operazione
dimostrò la credibilità dell'organizzazione messa in piedi dagli uomini
dell'ORI e favorì il progetto di costituzione di un reparto armato alle dirette
dipendenze dell'ORI e dell’OSS. Farneti contattò il Comitato Militare di
Ravenna comunicando l'intenzione di costituire una brigata, nella quale far
confluire i gruppi armati di Faenza, Brisighella e Castelbolognese, a capo
della quale sarebbero stati i faentini Vittorio Bellenghi (Nico), Bruno Neri
(Berni) e Vincenzo Lega (Nello), in qualità, rispettivamente, di comandante,
vice comandante e capo di Stato Maggiore, e Gino Monti come commissario
politico.
I
reparti partigiani, che operavano sulle colline, avevano continuamente necessità
di rifornimenti di armi e di esplosivi; cosi tramite la radio vennero
organizzati altri aviolanci. La zona scelta era quella del Monte Faggiola per
approvvigionare la 36^ Brigata Garibaldi. Quando il 15 giugno Radio Londra
trasmise la frase in codice "Un caffè sport", i partigiani si
recarono nella zona prevista dove un aereo alleato lanciò il suo carico. Per le
settimane successive furono pianificati nuovi lanci. II
5 luglio si concretizzo il progetto di formazione di un reparto autonomo dell'ORI,
che venne denominate "Battaglione Ravenna", composto da una
sessantina di uomini. Nei giorni successivi fu organizzato, per una data fra il
16 e il 20 luglio, un aviolancio sul monte Lavane per equipaggiare
convenientemente il battaglione.
II battaglione era concentrato nei pressi del
monte Cavallara, a nord di Lutirano, e doveva spostarsi nella zona
dell'aviolancio. Durante il trasferimento, nei pressi del cimitero dell'eremo
di Gamogna, Bellenghi e Neri, che precedevano il gruppo dei partigiani, ebbero
un conflitto a fuoco con un battaglione di tedeschi e rimasero uccisi dopo un
breve scontro. A seguito della contemporanea perdita del comandante e del vice
comandante sfumò il progetto di avere un reparto autonomo dell'ORI e gli uomini
che lo componevano confluirono in parte nella 36^ Garibaldi e in parte nei
Gruppo di Corbari.
|
Il lancio di rifornimenti previsto per la meta di luglio avvenne
lo stesso regolarmente nella zona del Monte Lavane il 17 di luglio e il
materiale fu raccolto dalla banda di Corbari, con il quale Virgilio Neri era da
tempo in contatto.A seguito dell'uccisione di Bruno Neri, fu anche deciso la
spostamento della radio poiché la villa di Rivalta non era più ritenuta un
posto sicuro, in quanto vi era sfollata la sua famiglia, ed era probabile che
potesse esserci una perquisizione da parte dei tedeschi. La valigia con la
radio fu spostata a Pieve Cesato nella casa di Pietro Fabbri, che collaborava
già con il gruppo dell'ORI, dalla staffetta partigiana Rina Zaccaria, fidanzata
di Farneti, con un lungo giro in bicicletta. Qui risiedeva anche il
radiotelegrafista Zanco, che quotidianamente inviava e riceveva dei messaggi. II
28 luglio, arrivarono alla casa alcuni militari tedeschi che cercavano un luogo
per sistemare delle cucine da campo. Il radiotelegrafista, seduto all'aperto
sotto un pergolato, era intento a preparare messaggi da inviare.
Inspiegabilmente continuò il suo lavoro, e, quando i tedeschi gli si avvicinarono,
tentò di nascondere i cifrari e di fuggire attirando la loro attenzione. Scoperto,
fu portato al comando tedesco e picchiato per farlo parlare. Fu individuate
anche il nascondiglio della radio. Nei giorni immediatamente successivi, Pietro
Fabbri, che non era in casa al momento dell'arresto di Zanco, si presentò spontaneamente
alla Gestapo per salvare i suoi familiari, che erano in mano ai tedeschi.
Tradotto nelle carceri di Forlì, vi fu fucilato l'8 agosto. Il 31 luglio, nella
parrocchia di Villafranca, Farneti si incontrò con gli altri del gruppo e fu
deciso di disperdersi per non essere arrestati, nei timore che il
radiotelegrafista sotto tortura avesse rivelato i nomi dei compagni. Nei giorni
seguenti vennero presi, per una serie di sfortunate coincidenze, Vincenzo Lega
e Tonino Spazzoli, poi fucilati.

|

|

|
Piero Fabbri (1912-1944),
per evitare rappresaglie alla famiglia, si consegnò
ai tedeschi, fu imprigionato a Forlì
e venne successivamente fucilato.
|
Vincenzo Lega (1915-1944),
ufficiale dell'Esercito, collaboratore dell'Ori,
capo
di stato maggiore del Battaglione Ravenna.
Catturato dopo la scoperta della radio fu
imprigionato e fucilato a Forlì. |
Domenico Montevecchi (1909-1944),
catturato poco tempo dopo lo sbarco in Istria,
fu imprigionato a Verona e poi
fucilato a Bolzano il 12 settembre 1944.
|
Virgilio
Neri andò a Milano per prendere contatto con il Comitato di Liberazione
Nazionale. Catturato casualmente dai tedeschi durante un rastrellamento, riuscì
a fuggire dal vagone che lo portava in Germania. Anche Corbari e i principali
esponenti del suo gruppo vennero catturati ed uccisi, il 19 agosto, a seguito
della cattura di radio Zella. Farneti prese allora contatto con un'altra
missione ORI, che operava nella zona di Alfonsine ; riprese i contatti con i
gruppi partigiani e riuscì ad organizzare un aviolancio nella zona di Savarna.
Ricevette anche un nuovo apparecchio radio e un radiotelegrafista, ma non riuscì
più a mantenere contatti continuativi con la base dell'OSS. A metà di ottobre
del 1944, quando il fronte era già in Romagna, Farneti, unitamente ai faentini
Carlo Maltoni e Alfredo Nediani, all’avvocato Tarroni di Cotignola, dopo alcuni
giorni di avventuroso cammino, raggiunse le truppe alleate nei pressi di S. Benedetto
in Alpe. Terminava cosi la missione "Zella" dopo otto mesi di duro e
pericolosissimo lavoro. Gli uomini dell'organizzazione tramite la radio avevano
trasmesso oltre 100 messaggi agli Alleati, fornendo preziose informazioni.
Altri gruppi dell'ORI continuarono ad operare nell'Italia del nord fino alla
Liberazione. La storia dell'ORI non è molto conosciuta, ma l'organizzazione ha
avuto un ruolo importante nella Resistenza, dimostrando che un piccolo reparto
composto da persone ben motivate poteva operare, con pari dignità, a fianco
delle truppe alleate. II prezzo pagato in termini di vite umane è stato alto,
sia tra i membri fondatori dell'organizzazione, sia tra quelli che vi avevano
aderito successivamente nelle zone occupate. La nostra città ebbe cinque
caduti: Vittorio Bellenghi, Pietro Fabbri, Vincenzo Lega, Bruno Neri e Domenico
Montevecchi. In loro onore, riportiamo la lettera fatta recapitare a radio
Zella dal capitano Corvo dell'OSS il 20 giugno 1944: "Voglio esprimere la
mia gratitudine e quella di tutto il Comando per l'attività svolta da voi. Le
vostre attività sono di molta importanza non solo per gli Alleati, ma anche per
la futura Italia.... Da parte nostra vi promettiamo tutto l'aiuto possibile in
armamenti e altri materiali che vi bisogneranno...." .
|

