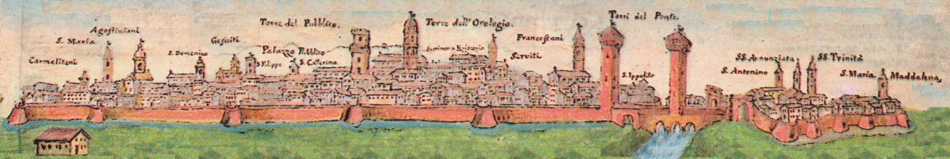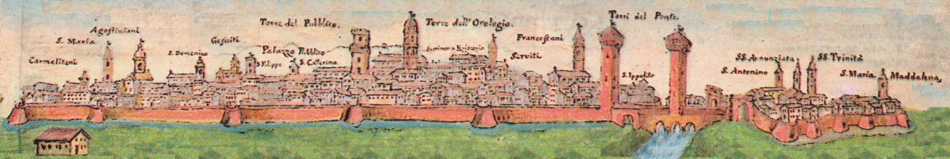|
Pistocchi Giuseppe
di Rino Savini
da: I faentini dello stradario, Grafiche Galeati, Imola, 1986.
Era tradizione che famiglie nobili, o qualche monsignore aiutassero i
giovani che dimostravano talento nelle arti e nelle scienze. Accadde
cosi, che Giuseppe Pistocchi, figlio dello scalpellino Antonio, fosse
aiutato dal vescovo di Faenza, Antonio Cantoni. Giuseppe Pistocchi era
nato in detta città il 12 gennaio 1744. Frequentò la Scuola di Disegno
architettonico sotto la guida di Giuseppe Boschi, detto il Carloncino.
A diciotto anni il giovane Pistocchi diede un saggio della sua bravura
disegnando la Piazza di Faenza, tanto bene, che l'incisore Giuseppe
Ballanti Graziani volle riprodurla nella sua ben nota stampa. A questo
punto il vescovo Cantoni mandò Pistocchi prima a Ravenna, poi a Roma a
perfezionarsi presso l'architetto vanvitelliano, Carlo Murena. Oltre alla scuola, a Pistocchi fu di grande giovamento il contatto con
i meravigliosi monumenti della città eterna. II vescovo Cantoni, che lo
teneva sotto la sua protezione, lo presentò alla Curia Romana, che lo
inviò nelle Marche con la qualifica di Architetto Camerale. Pistocchi,
in tale veste, a Pesaro, provvide al restauro del Palazzo Apostolico,
della Rocca Paolina, ed al trasporto e alla relativa sistemazione della
statua di Urbano VIII. Poi, diresse le opere di consolidamento del
forte di San Leo.
A Senigallia costruì il Palazzo Grossi. E’ ovvio che il suo protettore
desiderasse avere un saggio del suo genio e gli commissionò il progetto
dell'altare maggiore del Duomo di Faenza. Non è certo un capolavoro
quello che ne sortì, e che tuttora si vede; l'altare dimostra
l'immaturità del disegnatore e la soggezione scolastica ai maestri
romani. Fanno spicco, tuttavia, i materiali messi in opera. La maturità
e la personalità dell'artista Pistocchi, si manifestarono quando, nel
1771, da Roma mandò a Faenza, al costruttore capomastro Gioacchino
Tomba, i disegni della chiesa dei SS. Ippolito e Lorenzo. II riminese
Antonio Trentanove arricchì l'interno con decorazioni, bassorilievi e
statue in modo da rendere il tempio uno dei più belli della città.
Giuseppe Pistocchi, da buon romagnolo, sentiva la nostalgia della sua
terra e perciò si fece trasferire a Faenza. I compiti, qui, non mancarono: c'era il ponte Manfrediano, con le due
torri, da restaurare, cosa che fece conservandone tutte le
caratteristiche; poi, fu la volta della costruzione del palazzo
Bandini-Spada, in corso Porta Imolese (ora Mazzini); ed altre opere
importanti. Per il valore che andava dimostrando e per quell'attaccamento
affettuoso che lo legava all'artista, mons. Antonio Cantoni nominato
arcivescovo di Ravenna, chiamò il Pistocchi affinché ricostruisse la
nuova cupola della Cattedrale, in sostituzione di quella mal riuscita
del Buonamici. Mentre attendeva a quest' opera, che lo tenne impegnato
per circa tre anni. Pistocchi ricevette l’incarico dall’Accademia dei
Remoti di costruire il nuovo teatro a Faenza. Egli presentò un progetto
che sovvertiva tutte le tradizioni sia nella forma architettonica, sia
nella disposizione acustica. Però, la somma che inizialmente era
sembrata sopportabile, si manifestò ben presto appena sufficiente per
un quarto dell'opera. Sorsero quindi difficoltà e contrasti che
provocarono interrogazioni e non poche amarezze all'architetto. Ma
tutto dimenticò quando il teatro fu inaugurate la sera del 12 maggio
1788 con l'opera Caio Ostilio del Giordanello, e con il ballo pantomina
Castore e Polluce. Le lodi che Pistocchi ricevette erano pienamente
meritate; infatti la sala, decorata sapientemente con le statue e i
bassorilievi del Trentanove ed affrescata da Antonio Valiani e da
Serafino Barozzi, oltre che ad essere un gioiello di eleganza, si
rivelò di un acustica perfetta.

Palazzo Gessi, corso Mazzini 54,. Giuseppe Pistocchi, 1786.
|
Poiché
si volle collegare la residenza municipale con il nuovo teatro,
si diede l'incarico a Pistocchi di provvedervi ed egli compì un altro
capolavoro costruendo la Galleria dei Cento Pacifici. Sulle ali
dell'entusiasmo Pistocchi tentò di inserirsi nell'agone internazionale,
presentandosi al concorso di Venezia per il nuovo teatro che si doveva
chiamare «La Fenice». Quando Pistocchi seppe che la giuria doveva
favorire l'architetto veneziano Gian Antonio Selva, non inviò la
perizia di spesa, perciò il suo progetto non fu posto nemmeno in
graduatoria. Non per questo l'opera prolifica dell'artista rallenta;
anzi, è del
1791 la costruzione del Pelatoio e del Macello Pubblico, sulle mura
Diamante Torelli; seguono, poi, il palazzo Gessi e l'incompiuto palazzo
Conti-Guidi, e la sua casa in corso Porta Imolese a Faenza. II
desiderio e l'ardore per le cose nuove lo spingono alla ricerca
della cultura d'oltr'Alpe, attraverso canali segreti; questo era
sufficiente, nello Stato Pontificio, per essere tacciati di
rivoluzionari e giacobini. Siccome le idee nuove in arte sono unite a
quelle di libertà, Pistocchi riunisce nella sua casa i propagatori
delle nuove idee ed egli stesso ne diventerà uno dei più fervidi
diffusori. Alla polizia dello Stato Pontificio non sfuggirono queste
tendenze ribelli e c'è da credere che, nell'intento di legarlo alla
Chiesa, fu inviato a Faenza il cardinale legato Nicolò Colonna di
Stigliano per conferire a Pistocchi il titolo di cavaliere dello
Sperone d'Oro, a riconoscimento dei meriti di artista e come ricompensa
alla sua attività di architetto della Camera Apostolica. Pistocchi non
si commosse ne si ricredette! Nel contempo riceve dal conte Francesco
Milzetti l'incarico di
costruire un palazzo in via Tonducci, nel luogo in cui esistevano già
delle case di proprietà del conte. |
Questi voleva che il suo palazzo
potesse gareggiare con quelli dei principi e dei ricchi patrizi
faentini. L'opera non poté essere portata a termine dal progettista,
perché quando nel 1799 fecero ritorno le milizie austro-pontificie,
Pistocchi fu imprigionato e la prosecuzione dei lavori fu affidata
all'architetto Giannantonio Antolini di Castelbolognese. Sarà proprio
l'Antolini la pecora nera del Pistocchi; infatti, un primo dispiacere
l'ebbe quando l'amministrazione giacobina, non attendendo la
liberazione di Pistocchi dalla prigionia, affidò all'Antolini
l'incarico di costruire sulla via Emilia, all'altezza della chiesa del
Paradiso, l'Arco a ricordo della vittoria delle truppe francesi su
quelle papaline al Ponte di San Procolo (2 febbraio 1797). A sua consolazione, il Pistocchi venne nominato Ispettore Generale
delle Caserme del Dipartimento del Rubicone e ingegnere idraulico del
canale Naviglio.

Palazzo Milzetti, via Tonducci 15. Giuseppe Pistocchi, 1792.
|
Per essere più vicino al Governo Centrale
Repubblicano, egli, nel 1801, si trasferì a Milano dove assunse
l'incarico di Architetto dei Quartieri Militari. E, nella capitale
lombarda trova, ancora, l'Antolini che già si era affermato col famoso
progetto del Foro italico, ribattezzato, poi, col nome di Foro
Bonaparte. L'accanimento posto dal Pistocchi per avere una rivincita
sul rivale fu espresso nei numerosi progetti presentati ed in gran
parte non realizzati. Fra questi progetti vanno ricordati quello per
Porta Sempione e Porta Ticinese; quello per la costruzione di un
Palazzo Reale sull'area dei ruderi del castello Visconteo; quello della
sistemazione chiusa a portici della piazza del Duomo; e quello di un
ponte sul Ticino che per slancio strutturale si può definire
precorritore di moderne strutture. Durante il soggiorno milanese, Pistocchi venne frequentemente a Faenza,
tanto che nel 1803 ebbe l'incarico di costruire l'Arco Trionfale, nei
pressi di Porta Imolese (quello fatto dall'Antolini era stato abbattuto
nel 1799) in onore di Napoleone che doveva venire a visitare la
Romagna. Inoltre, è di quel periodo la costruzione della casa posta in
corso Mazzini al n. 71 e quella in corso Garibaldi al n. 9, detta
«dell'Aquila». Nel 1806, Pistocchi ottenne l'incarico di Direttore dei Palazzi Reali
di Mantova. Qui progettò una nuova sistemazione della Porta Pradella.
Come ultimo suo lavoro di grande impegno presentò il progetto per il
concorso del monumento sul Moncenisio voluto da Napoleone; progetto che
non poté essere realizzato per eventi politici. Quando nel 1813 ottenne
la sospirata ed ambita cattedra universitaria a Pavia, egli,
sfortunatamente, si ammalò di tumore al piloro. Non volle morire
lontano dalla sua città natale, perciò si fece portare nella sua Faenza
ove spirò il 20 agosto 1814. Fu sepolto nel cimitero napoleonico in
località di San Rocco, lungo la via Ravegnana. Poi, nel 1825, amici
fedeli vollero onorarne la memoria collocando nella Cattedrale un
monumento di stucco, opera dei fratelli Ballanti Graziani, su disegno
di Gaetano Bertolani.
|
|