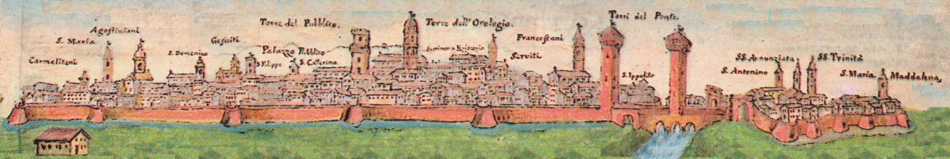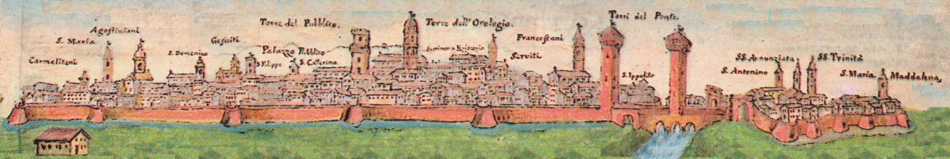|
San Nevolone (Beato Novellone)
di Luisa Donati Renzi
Le notizie più antiche e sicure
intorno al Beato Novellone ci sono fornite dal notaio a lui contemporaneo
Pietro Cantinelli, il quale nella sua Cronaca
riporta che tutti i Faentini lo ritenevano santo anche prima della morte,
avvenuta il 27 luglio 1280 presso la “Cella di fra Lorenzo”, un eremitaggio
camaldolese fondato nel 1253 in
un orto del sobborgo della Ganga, situato dietro all’odierno Museo
Internazionale delle Ceramiche. Ricorda il cronista che Nevolone, in seguito ad
un’infermità a tutti nota, morì poco dopo le tre del pomeriggio, di sabato, e
che il suo corpo fu trasferito in Cattedrale in quello stesso giorno, con la
partecipazione di tutto il clero e il popolo della città. Non viene fatta
alcuna menzione del vescovo: dalle carte del tempo risulta che nel luglio del
1280 la cattedra episcopale faentina era vacante.
G. C. Parini, che nel 1683
scrisse una vita del Beato intitolata Il
pellegrino indefesso, aggiunge che, durante il suo funerale tutti a gara
desideravano portarlo sopra le spalle e che “alcuni lo accompagnavano con
pianti, singhiozzi e lamentevoli voci,…altri esortavano tutta la città alla più
solenne allegrezza per aver acquistato in cielo un nuovo e potentissimo
avvocato”. Un Anonimo ecclesiastico faentino,
che tra il 1415 e il 1474 scrisse lui pure una biografia del Santo, riferisce
che, alla morte di Nevolone, le campane suonarono per movimento spontaneo. La vita di questo Beato ci
riporta indietro di più di otto secoli, in una Faenza in cui le case cominciavano
ad essere costruite in mattoni, le vie ad essere selciate, i canali regimentati
con argini in pietra, la rete fognaria allestita sotto terra, gli animali, come
capre e maiali, allontanati dalle vie cittadine. E ci riporta in una campagna
coltivata a cereali, lino e vigneti, frequentemente devastata dal continuo
stato di guerra, dove nei campi abbandonati si moltiplicavano gli animali
selvatici, tanto che “fagiani, pernici e quaglie, lepri, caprioli e cervi,
bufali, lupi e cinghiali non trovando più nutrimento… si avvicinavano
minacciosi alla città”. I lupi, radunati in gran numero, levavano alti ululati
per la fame e di notte penetravano dentro le mura divorando gli uomini
addormentati, le donne, i fanciulli. Anche le volpi si erano moltiplicate e Salimbene
da Parma racconta che due di esse, per inseguire delle galline, si
arrampicarono sul tetto dell’infermeria dei frati minori di Faenza. Anche il
restringersi del bosco deve aver condotto molte bestie selvatiche a cercare
cibo altrove: emblematico è il caso di Gubbio, dove il lupo affamato trovò in
S. Francesco un valido, e insieme cordiale, interlocutore. Novellonus, accrescitivo di
Novellus, era nome frequentissimo nella nostra città nel secolo XIII. La sua
trasformazione in Nevolonus passa attraverso la voce dialettale Nuvlòn, che gli
scrittori tradussero in latino, interpretandola come accrescitivo di “nuvolo”.
S.
Nevolone nacque intorno al
1200: da quale famiglia provenisse e a quale ceto sociale appartenesse
è
difficile desumere dalle fonti che attraversano i secoli, fino al XIX.
Esse
tramandano i nomi dei genitori, Giovanni e Maria, parlano di una loro
condizione agiata, ricordano che la madre, rimasta vedova, si affrettò
a far
sposare il figlio che si era lasciato condurre dalle passioni, nella
speranza
che si convertisse e che, continuando a pregare per lui, fu esaudita.
Malato a
morte, Nevolone promise al Signore di cambiare vita e, ristabilitosi in
salute,
mantenne la promessa. E’ possibile che a Faenza il
Santo abbia esercitato il mestiere del ciabattino: i calzolai della
città fin
dal 1331 si astenevano dal lavoro nel giorno della sua festa; inoltre
nel 1351
la loro Arte prese una sua deliberazione “vicino all’altare del beato
Nevolone
nella cattedrale di san Pietro” e nelle matricole dei secoli XIV e XV
si trovano quattro calzolai che portano il suo nome. Da ultimo, il
canonico Andrea Strocchi, in un
opuscolo datato 1845, ricorda che “poiché era suo mestiere l’acconciare
scarpe,
lavorava per coloro che non potevano pagare, ricevendo da Dio manifesti
segni
di grazia”.
Fu poi certamente, come dice la
già ricordata Cronaca del Cantinelli,
“de ordine fratrum Penitentie terci ordinis sancti Francisci”. Il movimento della Penitenza, che
coinvolse centinaia di laici di entrambi i sessi a partire dai primi anni del
secolo XIII, rappresenta un fenomeno spirituale e sociale che trovò
nell’ambiente francescano incoraggiamento e sostegno. I penitenti erano laici
devoti, particolarmente attaccati ai vescovi e al papa, che si caratterizzavano
per una scelta di pace e di lavoro. A Faenza sono documentati pochi anni dopo
la morte del B. Nevolone: quattro di loro parteciparono quali rappresentanti
della città al Capitolo Generale dei fratelli dell’ordine della Penitenza che
si tenne a Bologna nel 1289, a
testimonianza di una presenza continuativa e stabile nel tempo.S. Nevolone è quindi inserito in
un contesto spirituale, quello dei terziari francescani, che sottolinea
l’importanza e il ruolo della vita religiosa dei laici, ed appartiene alla
categoria, che ebbe grande fortuna alla fine del Duecento, dei santi della
carità e del lavoro di cui troviamo rappresentanti in ogni città della Penisola,
dalla Cremona di S. Omobono alla Siena del dantesco Pier Pettinaio.
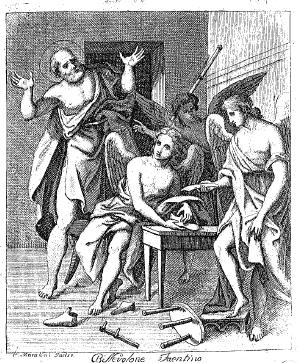
|

|
Vincenzo Marabini (sec. XIX prima metà) S.
Nevolone rientra in bottega dopo aver passato il suo tempo a pacificare
gli animi e trova gli angeli che lavorano in sua vece. In basso a
sinistra “V. Marabini Incise”. Al centro“B. Nevolone Faentino”Acquaforte (170 x 135 mm)
Faenza Biblioteca Comunale Manfrediana.
|
San
Nevolone mentre è al lavoro ha una visione angelica: dalla porta
spalancata della bottega si vedono i loggiati della piazza di Faenza.
|
Era anche un pellegrino: il
canonico Andrea Strocchi, nel suo opuscolo del 1845, riferisce che il Beato
subito dopo la sua conversione, avendo come protettori i SS. Apostoli Pietro e
Paolo, e S. Giacomo Maggiore, decise di visitare i luoghi dove si conservavano
le ossa di questi santi, camminando “in rozzo abito, col piede nudo, capo scoperto
e con la disciplina per viepiù macerare il corpo” e che “fu veduto cambiare con
poverelli le vesti, e prendere le più lacere”. Si recò a Santiago di
Compostella undici volte e quasi altrettante, ma la notizia è meno certa, a
Roma. L’Anonimo ecclesiastico faentino del Quattrocento racconta che, nel suo
secondo viaggio alla tomba dell’apostolo Giacomo, la moglie lo pregò di
portarla con sé e che, colpita da grave infermità lungo il cammino, fu presa
dal desiderio di mangiare delle ciliegie. Era inverno, ma Nevolone, non
dubitando della misericordia di Dio, si allontanò quanto un tiro di sasso e,
prostrato a terra, levò gli occhi al cielo dicendo: “Signore Dio onnipotente,
che hai fatto il cielo e la terra,…abbi misericordia di me e non disprezzare il
tuo servo che hai redento a caro prezzo, ma esaudisci la mia preghiera e sii
propizio alla mia compagna nella sua infermità, per la quale grido a Te
affinché vivi possiamo lodare il tuo nome, che è benedetto nei secoli dei
secoli”. Finita questa preghiera, subito apparvero su una pianticella delle
ciliegie, che egli raccolse e portò alla moglie la quale, dopo averle gustate, guarì
dalla sua malattia. Così poterono proseguire il cammino “lodando insieme Iddio
che non abbandona quelli che sperano in Lui”. Una pala con questo tema
iconografico si trova nella chiesa intitolata a San Giovanni di Dio dell’Ospedale
degli Infermi, voluto dal vescovo Antonio Cantoni per rispondere a rinnovati
criteri di igiene e di ricovero, che mantiene viva la memoria dei due ospedali
più antichi della città, quello di S. Antonio abate e quello del B. Nevolone.

Francesco Foschini (Faenza 1733 - Lisbona 1805) San Nevolone e il miracolo delle ciliegie, olio su tela, cm 200 x 140. Faenza chiesa di San Giovanni di Dio.
|
Pietro Cantinelli nella sua Cronaca collega digiuni, penitenze e
pellegrinaggi, suggerendo che in cinque di questi S. Nevolone si flagellava
lungo la strada. E’ noto come nel 1260, venti anni prima della morte del Beato,
cominciassero a Perugia le processioni dei flagellanti o battuti che, a due a
due, ignudi dal capo ai lombi e armati di sferza di cuoio o di strumento
simile, si flagellavano a sangue emettendo alte e flebili voci. Dall’Umbria
passarono in Romagna e si diffusero altrove, fino a quando furono proibite dal
papa Urbano IV (1261- 64). Ma, secondo il Muratori, l’uso di flagellarsi fu
ripreso da società e consorzi di privati, donde ebbero origine le compagnie o
confraternite dei battuti, fiorite specialmente nei secoli seguenti (XIV e XV).
E infatti anche a Faenza le confraternite con il nome di “Battuti bianchi” o
“gialli” o “rossi” o “neri” ecc. (dal colore della loro cappa) cominciarono
solo verso la metà del secolo XIV. Neppure la Confraternita dei battuti bianchi, detta anche Societas sancti Nevoloni, che
amministrava l’Ospedale di S. Maria della Misericordia o el Spedal Novo, poi lo
Spedale di Madonna bianca ed anche di
S. Nevolone può vantare come istitutore e legislatore il nostro Beato. Non
è impossibile però che qualcuna di esse, forse la prima, avesse lui come suo
fondatore, il quale con il suo esempio aveva lasciato una traccia che i membri
delle varie confraternite di battuti seguirono: vivere per attendere alla
famiglia, alla beneficenza, al servizio di Dio (Francesco Lanzoni).
Il cristiano non era tenuto al
pellegrinaggio, tuttavia esso rievocava il cammino di Adamo fuori dal Paradiso
terrestre, il fatto che i patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe non avessero
fissa dimora, la fuga in Egitto, il viaggio dei Magi, il cammino dei discepoli
di Emmaus… E la conformazione geografica dell’Europa, il suo clima (non si
viaggiava dalla festa di S. Martino a quella della Cattedra di S. Pietro, cioè
dall’11 novembre al 22 febbraio), la fede in Dio e la fiducia nei santi suoi
amici (S. Martino per i Franchi, S. Bonifacio per i Tedeschi, S. Patrizio per
gli Irlandesi, S. Stefano per gli Ungheresi) che con la loro azione, le loro
sofferenze, o per essere stati sepolti in un determinato luogo lo hanno
santificato, hanno favorito nel Medioevo
viaggi anche lunghi, con una molteplicità di mete, soprattutto Santiago di
Compostella, Roma, Gerusalemme. Lungo il cammino il pellegrino sperimentava il
freddo e la fame (l’importanza del pane è chiaramente indicata dal termine
tedesco Kumpan, in francese copain, colui con il quale si condivide il pane),
la sete, la stanchezza, i pericoli rappresentati dagli animali, dai malintenzionati, talvolta
dagli osti… Per questo era solito viaggiare associandosi ad un piccolo gruppo,
doveva alla partenza mettersi in pace, e riceveva dal sacerdote, insieme alla
benedizione, un bastone e una bisaccia. |
Restano a sottolineare il
pellegrinaggio di S. Nevolone due statue, una in stucco collocata entro nicchia
presso l’altare del SS. Sacramento in
Cattedrale, opera del faentino Giovanni Collina Graziani (1862), che
sostituisce l’antichissima in legno (risalente al sec. XV, distrutta da un
incendio, il cui troncone, risparmiato, la pietà dei fedeli volle racchiuso
all’interno dell’attuale) e una in cartapesta policroma, ora nella chiesa di Sant’
Antonio, sede dell’Associazione del Beato Nevolone (proveniente dall’ Asilo
dell’ Istituto Righi delle Terziarie Francescane).
Nel 1275 il Generale dei Camaldolesi, Gherardo, avrebbe proibito a
Nevolone di intraprendere altri viaggi data l'età avanzata,
consigliandogli piuttosto digiunie orazioni, che furono accettati con
spirito di ubbidienza, fino alla morte. “Dio onnipotente si degnò di fare
molti, grandi e propizi miracoli per i meriti di detto frate Novellone”, e il
popolo da subito lo credette “un santo presso Dio per la bontà, l’onestà e la
vita molto impegnata in virtù congiunte a grande penitenza”, contendendosi,
dopo averli ricercati affannosamente, i suoi indumenti personali per farne
reliquie. Questo è quanto ancora riportato da Pietro Cantinelli nella sua Cronaca.
S. Nevolone fu
sepolto in Cattedrale in un’arca, collocata nel luogo dove egli era solito
recitare il “Mattutino”, talmente frequentata che dal 1282 ebbe un guardiano
particolare. La memoria della santità di questo umile ciabattino rimase viva
nei secoli, come testimonia una moneta di età manfrediana, la quale reca da un
lato, alla sommità una crocetta greca, nel campo l’impresa della lancetta chirurgica
aperta, con gocce di sangue, ed attorno la legenda “ASTORGIUS FAVENT. D.
(Astorgius Faventiae Dominus), e dall’altro lato una figura d’uomo mezzo
ignudo, con un ginocchio a terra e col capo ornato di luce, ed attorno la
legenda “B. NOVOLONUS (Beato Novellone). Nel 1614, per decreto del card.
Erminio Valenti, vescovo di Faenza, il suo corpo, collocato in altra urna,
lasciò l’altare un tempo a lui dedicato e fu trasferito nella cappella di S.
Andrea Apostolo, ora del SS. Sacramento; quasi un secolo dopo il vescovo, card.
Marcello Durazzo, dopo averlo fatto rivestire di broccato berettino, stabilì
che venisse posto sotto l’altare nella cappella dei SS. Pietro e Paolo, ora
santuario della Beata Vergine delle Grazie. Da qui, il 30 giugno 1765, essendo
vescovo Antonio Cantoni, fu trasferito nel luogo dove ancora oggi si venera.

A, Barbiani La gloria del B. Nevolone e scene di pellegrinaggi iberici. Faenza Basilica Cattedrale.
|
La
cappella di S. Nevolone, prima dedicata ai SS. Lorenzo e Filippo Neri,
raffigurati insieme alla Madonna con il Bambino nella pala d’altare
dipinta da G. Francesco Gessi, è situata nella testata del transetto
destro della Cattedrale. L’ Arte dei Calzolai e Callegari (Sodalitas
Sutorum, come si legge in un’epigrafe commemorativa) che nei
secoli aveva custodito con grande venerazione la memoria del suo Santo
protettore, si fece promotrice dell’impresa decorativa che affidò al
pittore ravennate Andrea Barbiani (1708- 1779). Tutta la città
partecipò con vivo entusiasmo ai lavori, quando si scoprì la volta, il
6 ottobre 1764, ed ancor più quando fu inaugurata l’ intera cappella,
il 28 giugno 1765, vigilia della festa di S. Pietro. Il cronista Paolo
Monti racconta che in quel giorno si scoprì tutta la bella cappella
“del nostro San Nevolone pitturata, ed affatto terminata dal celebre
Barbiani di Ravenna, a suono di Trombe e di Tamburi, ed ad un tratto si
viddero una quantità di sonetti in lode del bravo Pittore”.
Lo
spazio è interamente occupato dai dipinti, in parte ad affresco, in
parte ad olio lumeggiati in oro. Nella volta è rappresentata la gloria
del B. Nevolone, portato in volo dagli angeli e accolto in cielo dai
SS. Pietro e Paolo e Giacomo Maggiore che scendono tra nubi e gruppi di
angeli. Una luce dorata, irradiata dall’alto, investe la sua figura
scarna, dal volto emaciato, i capelli e la barba incolti, il dorso nudo
dei flagellanti e una gamba scoperta come S. Rocco, anche lui
pellegrino. Intorno, su diversi piani, stanno angioletti che volano e
che suonano; uno di essi, ai suoi piedi, reca il bordone. Nello sfondo
è una luce azzurra di cielo naturale, soffusa qua e là di nuvole
bianche. Nei pennacchi sono dipinti quattro episodi che si riferiscono
ai suoi pellegrinaggi: 1) In viaggio verso Santiago di Compostella,
affranto dalla stanchezza, vede comparire un angelo con un cavallo che
lo solleva prendendolo con sé; 2) Per compiacere alla moglie morente,
che chiede delle ciliegie per ristorarsi, ottiene con la preghiera che
un albero, benché d’inverno, produca di questi frutti; 3) Estenuato
dalla fame, trova una moneta con cui pagare l’oste che gli aveva
rifiutato il pane; 4) Libera un indemoniato gettandogli addosso la sua
cappa.
|
Nelle pareti laterali si sviluppa
una decorazione a chiaroscuro con putti e festoni contenente in ciascun lato
due grandi scudi ovali sostenuti da angeli e circondati da un panneggio
violaceo a frangia d’oro che poggiano su basamenti prospettici: in quello di
destra è rappresentato un miracolo di S. Nevolone, la moltiplicazione dei pani
nella madia; in quello di sinistra gli angeli compiono il lavoro da calzolaio,
mentre il Santo attende alle opere di carità. Nei basamenti due scene a
monocromo ritraggono rispettivamente l’apparizione ai Faentini assediati dal
duca Valentino dei quattro Santi protettori della città (Savino, Pier Damiani,
Emiliano e Terenzio) insieme a Nevolone e il Beato in mezzo alla piazza mentre
esorta i suoi concittadini, travagliati dalle discordie civili.
 |
 |
|
Cappella del B. Nevolone.
Particolari con L’apparizione sulla città assediata dal Valentino e con l’opera
di pacificazione in mezzo alla piazza.
|
|
Ai lati stanno quattro figure di
Virtù: a destra l’Amore di Dio e la Vita Contemplativa, a
sinistra l’Amore del Prossimo e la Penitenza. Nelle
lesene del sottarco, tra motivi ornamentali, alcuni puttini con ampolle,
messale e campanello figurano i chierichetti che servono la Messa. Per raccontare gli episodi della
vita del Santo con il pennello, il Barbiani si servì della traccia offertagli
dai committenti, un’ altra Vita,
ispirata a quella dell’ Anonimo del secolo XV, tratta dalle Vite de’ Santi Beati Venerabili e Servi di
Dio della città di Faenza, un’ opera uscita nel 1741 dalla penna del dotto
sacerdote Romoaldo M. Magnani, della quale l’impresa decorativa sembra
conservare lo stesso tono, eloquente e ricercato, commosso e laudativo. Dopo la bufera napoleonica, nel
1817 il canonico Andrea Strocchi, vicario del vescovo Bonsignore, donò un nuovo
vestito per il corpo del Beato, che fu rimesso nell’antica urna. In tale
occasione “apparata elegantemente la
Cattedrale a spese di particolari devoti, a cui il Comune
contribuì colla somma di scudi 100”,
il 24 luglio fu portato all’altare maggiore. La domenica poi il Vescovo “fece
pontificale con Omelia allusiva alle geste del Beato, e nel dopo pranzo fuvvi
processione di quel sacro deposito. Essa movendo dalla Cattedrale s’incamminò
per la via degli Angeli (ora via XX Settembre) fino al Suffragio, dove entrata
nel Corso si condusse alla piazza e percorrendo le loggie vagamente apparate
tornò nella Cattedrale”. “Il 27 luglio 1818 per decreto della S. Congregazione
dei Riti… per la prima volta dal clero secolare di Faenza si recitò l’uffizio
con messa propria del B. Nevolone col rito di doppio minore”. Alla fine dello
stesso anno, il 27 dicembre, al suo altare “si fece la festa della B. V. detta
della Misericordia”, la cui immagine (ora al Museo Diocesano) “fu collocata in
apposita nicchia dietro l’altare” (da Memorie
storiche di Faenza/ raccolte/ dal Sac. Francesco Peroni Mans.). Essa doveva
trovarsi in origine nell’Ospedale di S.
Nevolone o di S. Maria della
Misericordia, che sorgeva nell’attuale vicolo dedicato al Nostro, situato tra
via Ugolino d’Azzo Ubaldini e via Campidori, dove egli aveva vissuto tra
preghiera, lavoro e penitenza la sua umile vita.
|