|
L'INIZIO DEL CULTO DI DANTE IN ROMAGNA
Giuseppe Dalmonte
(pubblicato sul mensile In Piazza, marzo 2020)
Se il 1797
è considerato l’anno di nascita del tricolore italiano, simbolo
patriottico per eccellenza, il 1798 segna invece la data di nascita del
culto risorgimentale al maggior poeta e padre della lingua italiana,
Dante Alighieri (1265-1321). Con l’avvento nella penisola delle
Repubbliche Democratiche, la loro organizzazione e suddivisione
territoriale nei vari dipartimenti, venti dei quali costituirono la
Repubblica Cisalpina, la Romagna fu suddivisa, nel biennio 1797-1798,
nel dipartimento del Lamone (capoluogo Faenza) e nel dipartimento del
Rubicone (capoluogo Rimini). Nel novembre 1797 i Commissari Luigi Oliva
e Vincenzo Monti furono inviati nei territori romagnoli per organizzare
in senso anti aristocratico l’amministrazione dell’Emilia, a fissare i
confini dei due dipartimenti e a insediare le due Amministrazioni
dipartimentali nei rispettivi capoluoghi. Nonostante le attese, il
comportamento dei due Commissari non incontrò il favore, in particolare
della Municipalità di Ravenna, che li accusò al Direttorio Cisalpino
per aver ecceduto nei poteri conferitigli smembrando a capriccio le
comunità e assumendo atteggiamenti dittatoriali, tanto che nel gennaio
1798 Oliva e Monti saranno richiamati a Milano per discolparsi davanti
al Gran Consiglio.

|
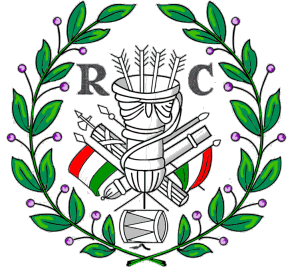
|

|
Domenico di Michelino. Dante e il suo poema, 1465.
Affresco nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze. |
Stemma della bandiera della
Repubblica Cisalpina.
|
Andrea Appiani, Vincenzo Monti (1754-1828),
1809,Pinacoteca Brera, Milano.
|
Con le
nuove condizioni politiche imposte dalla Repubblica Cisalpina, diventa
urgente formare un’opinione pubblica ben disposta nei confronti dei
francesi, propensa agli ideali democratici, repubblicani e patriottici,
che contrasti la propaganda ostile al nuovo regime politico alimentata
dagli avversari, con fogli volanti, opuscoli, giornali, e con
l’influenza sulle masse popolari della predicazione religiosa
cattolica. Questo compito d’indottrinamento democratico fu assolto dai
Circoli Costituzionali, ‹‹prime palestre di educazione politica››, che
si diffusero in Romagna durante questo biennio: a Cesena fu aperto il
terzo Circolo della Repubblica Cisalpina il 26 ottobre 1797, a Faenza
il 2 febbraio 1798, a Rimini solo il 29 aprile 1798. A Ravenna invece
fu inaugurato il 29 dicembre 1797 dai Commissari Luigi Oliva e Vincenzo
Monti, poeta originario di Alfonsine. Le due cariche principali del
Circolo erano di Moderatore e di Segretario, la prima fu affidata a
Paolo Costa (1771-1836) e la seconda a Jacopo Landoni (1772-1855),
ambedue letterati della città bizantina.
‹‹Con
grande solennità al suono della banda e con grande concorso di popolo
nella sala del vecchio palazzo della Municipalità s’inaugurò un
Circolo, che aprì quel giorno le sue sessioni››. Il cittadino Vincenzo
Monti rivolgendosi al numeroso pubblico intervenuto, attratto dalla
novità dell’evento, esaltò anzitutto il ruolo della Costituzione
‹‹questo sacro deposito della volontà generale, questo sublime
testamento della ragione, che vi restituisce il possesso di tutti i
vostri diritti, che vi dichiara eredi legittimi di tutti i beni morali
››, illustrò in seguito il ruolo del Circolo Costituzionale ‹‹fucina
dello spirito pubblico, … libero porto degli intelletti, ove approdano
da tutte le parti i pensieri della repubblica››. Concluse la sua
orazione esortando i cittadini ad avere coraggio contro i nemici della
Repubblica confortandoli con il paragone tra le rivoluzioni politiche e
le tempeste naturali che purificano l’aria e portano presto al sereno
dopo il fragore dei turbini. Intervenne pure il moderatore del Circolo
Paolo Costa, esponente di spicco dei giacobini ravennati, che ‹‹se
molto parlò di filosofia moderna, di privilegi scaduti, di meriti della
Nazione Francese, di superstizione e ignoranza … non fece nessun
accenno all’unità e indipendenza dell’Italia››. Il Commissario Luigi
Oliva parlò invece improvvisando, seguirono altri oratori, fra i quali
si distinsero il faentino Giacomo Laderchi a nome della Municipalità
della città del Lamone e il cesenate Biscioni. Da ultimo si alzò il
segretario della Commissione Della Porta che suscitò tra gli uditori
popolari qualche mormorio e rimprovero per le affermazioni fatte contro
la Chiesa, che aveva fatto onorare come eroi ‹‹gente che rinunciava ai
doveri della patria, per seppellirsi nelle solitudini, per conversare
con i bruti››. Tuttavia Della Porta ebbe poi l’idea più geniale e meno
servile nei confronti della nazione francese, avanzando la proposta di
onorare l’altissimo poeta, di cui Ravenna conservava gelosamente le
ceneri e ‹‹di proclamarlo cittadino ravennate››. La proposta fu
trasformata subito in mozione dal Commissario Monti e approvata
all’unanimità per onorare la memoria del sommo poeta, proponendo che il
prossimo mercoledì tre gennaio 1798 si celebrasse la festa in onore di
Dante.
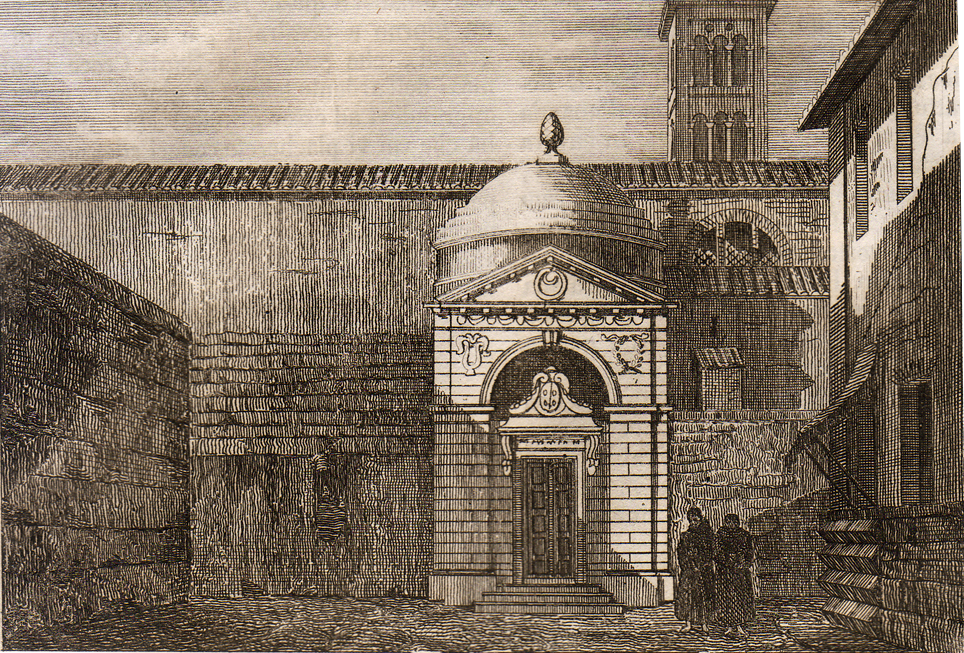
La tomba di Dante in una incisione del 1840.
|
Festeggiamenti in onore di Dante Alighieri e omaggio al suo sepolcro
Come
recitava la notificazione pubblicata dal moderatore Paolo Costa e dal
segretario Jacopo Landoni, alle ore 3 pomeridiane del 14 nevoso (3
gennaio secondo il vecchio stile) del 1798, ‹‹vedrete democraticamente
solennizzata la gloriosa memoria del Divino Dante, nostro
concittadino››. Dalla Sala del Palazzo Vecchio Municipale
‹‹s’incamminarono li Commissari con li Soci preceduti dalla Banda, e
accompagnati dai Civici Granatieri, e si avviarono per la Piazza verso
il Sepolcro di Dante. Era questa comitiva preceduta da un cittadino,
che sopra un alto leggile (leggio) portava la Divina Commedia con una
Ghirlanda d’alloro. Il Sepolcro era decentemente adorno di festoni e di
addobbi. Colà giunti, il Commissario Oliva, standosene in piedi sulla
Porta del sepolcro, fece una Allocuzione, colla quale significava, che
ad onore di quel Genio immortale, che era stato nostro ospite, si
solennizzava la festa››. A due muse cittadine di origine faentina fu
affidato il compito di offrire una ghirlanda di alloro e di fiori,
appese sopra la tomba del poeta. Una era l’ex contessa Maria Laderchi
moglie di Cristino Rasponi, l’altra Giuditta Milzetti sposa del
letterato Paolo Costa.
|
| Dal sepolcro il corteo fece ritorno al Palazzo
Municipale, dove si tenne una Seduta accademica in lode di Dante
Alighieri, alla quale parteciparono vari oratori. Il Commissario Oliva
diede prova della sua bravura nell’improvvisare il suo intervento, che
piacque a tutti sia per la franchezza sia per la pulizia nell’esprimere
i suoi concetti, come per il tono della voce nel declamare i suoi
versi. Paolo Costa recitò, chi dice due, chi invece un sonetto solo,
che in forme convenzionali esprimeva il pathos della città giacobina in
quei giorni di grande fermento. |

Corona di alloro e La Divina Commedia.
Carta da lettere della Repubblica Cisalpina,
la Libertà con beretto frigio omaggia Dante.
|
Poetic’ombra che dal lungo affanno
Vendicata risorgi al suon de’carmi,
Dì vai tu lieta dei funerei marmi
Che a mendicarsi nome erse un Tiranno?
………………………
Siam di ragione i figli, che non d’oro,
Ma di lauri a te cari offriam corona.
………………..
Dopo di
lui declamò un sonetto il Cittadino Prete Andrea Corlari, che attaccò
con energia la Curia Romana, la cui impostura era stata svelata nel
Divino Poema, scritto in gran parte a Ravenna, concluse perciò il
sonetto con l’invito a rendere omaggio al poeta:
…… I dotti inchiostri
Fur vergati fra noi. Da noi s’onori
Dunque il gran vate, il domator dei mostri.
Volle pure
inneggiare a Dante, libero cigno, anche un altro Cittadino Prete,
Martino Malagola membro di varie accademie ravennati:
Dante quel lauro, che il tuo crin circonda
D’oligarchica mano fa intreccio e dono,
Stilla sangue ogni ramo e par risponda
Sangue io son cui bevé l’ira d’un trono.
……………………..
|

Domenico Peterlin, Dante in esilio, olio su tela, 1860-65, Musei Civici (Vicenza).
|
Il protagonista
di questa seduta accademica in lode di Dante fu senz’altro il
Commissario Vincenzo Monti con il pubblico elogio del poeta recitato in
chiusura della cerimonia. Dopo aver riconosciuto i propri errori
giovanili nel considerare ‹‹barbaro il vostro Dante›› alla stregua di
tanti letterati, l’oratore ammise di aver mutato giudizio cogli anni,
tanto che i suoi versi divennero oggetto di meditazione, di diletto e
di ammirazione costante ‹‹e Dante fu ben presto il più dolce, il più
caro de’ miei pensieri››. Volendo spiegare il carattere aspro e ruvido
dello stile dantesco, Monti ricorda al pubblico che la bella lingua
italiana al tempo di Dante era bambina, perciò ‹‹prese egli
coraggiosamente a educarla, e questa lingua ruppe tosto le fasce, e
matrona, e gigante si fece nelle sue mani. Ogni lingua…non è che prole
ed immagine della mente, la quale i suoi concetti manifesta per la via
della parola. (…) nella vastità del soggetto trovando egli scarsa
suppellettile delle voci per adornarlo, tutte quelle introdusse nel suo
poema, che stimò significanti, ed adatte, qualunque ne fosse l’origine,
e la matrice. Altre ne fuse di conio proprio, altre ne tolse da’ fonti
greci, e latini, altre ne suscitò dall’antico, altre ne derivò dai
differenti italici dialetti›› tanto che solo lui può essere veramente
chiamato ‹‹padre dell’idioma italiano››, per l’acconcia collocazione
delle parole da cui deriva l’armonia e l’eleganza del suo stile. |
Nel
passaggio oratorio sull’analisi dell’ideologia politica dell’esule
fiorentino, che secondo i maligni non poteva meritare onori
repubblicani per aver ‹‹egli scritto un miserabile e sconosciuto
trattato sui diritti della Monarchia››, Vincenzo Monti cercò di
giustificare abilmente anche il mutamento delle proprie convinzioni
politiche precedenti accomunando la propria condizione a quella dei
sommi poeti Virgilio e Dante Alighieri, ora festeggiati con rito
repubblicano, dalla città di Mantova il primo e da Ravenna il secondo.
‹‹Si è perdonato a Virgilio, non si perdonerà all’Alighieri? Si è
festeggiata nella repubblica la memoria del favorito d’Augusto, e
s’insulterà a quella d’un infelice, che fu il flagello dei despoti. O
assolvete dunque l’Alighieri come avete assolto Marone, o private me
pure del sacro titolo di Cittadino. Anch’io, voi lo sapete, anch’io son
reo de’ medesimi loro delitti; anch’io nel suolo della romana tirannide
per campar la vita ho oltraggiato in un momento di vertigine, e di
terrore la libertà. (…) L’ombra di Dante è al mio fianco, e noi
aspettiamo amendue con sommissione, e silenzio la sentenza che darete
sul nostro errore››. Al termine della cerimonia fu fatta solenne
promessa di rinnovare ogni anno in questo giorno la memoria del Poeta
Fiorentino ora aggregato con tale atto alla Cittadinanza Ravennate.
|

