|
Il velocimano costruito a Faenza da Giuseppe Sangiorgi
(pubblicato sul mensile “In Piazza” di Confcooperative, dicembre 2006)
di Giuseppe Dalmonte
|
Tra
i numerosi appellativi affibbiati alla Romagna nel secolo trascorso,
quello più appropriato e attuale è senz’altro “terra dei motori e della
bicicletta” per motivi a tutti noti. Se rivolgiamo invece lo sguardo al
periodo pionieristico della bicicletta (cioè agli ultimi due decenni
del XIX secolo) dobbiamo menzionare almeno i nomi del poeta Olindo
Guerrini (alias Lorenzo Stecchetti, 1845-1916) e dello scrittore
faentino Alfredo Oriani (1852-1909), l’entusiasta cantore del
rivoluzionario veicolo. Celebrato in La Bicicletta nelle sue molteplici
forme di velocipede, triciclo, tandem e bicicletta, alla quale lo
scrittore ha dedicato pagine vibranti sulle sue appassionate galoppate
appenniniche e qualche cenno storico sulle principali fasi evolutive
della macchina da ‹‹giocattolo a strumento capace di superare il
cavallo e di lottare con il treno››. L’Ottocento della rivoluzione dei
mezzi di trasporto ha conosciuto due fasi distinte in questo
particolare settore: il velocipedismo prima e il ciclismo poi,
decollato però solo nella fase finale del secolo e all’inizio del XX
con l’affermazione universale della bicicletta. La fase arcaica è
caratterizzata dai celeriferi o velociferi francesi, macchine semplici
di legno, composte di una ruota anteriore collegata a quella posteriore
con un’asta, sormontata da una modesta sagoma di serpente, di leone o
di cavalluccio su cui sedeva e si aggrappava il cavaliere che a forza
di spinte alternate coi piedi sul terreno azionava la rozza macchina.
A Parigi nel 1800 si disputarono perfino gare con scommesse e
pochi anni dopo, si dice che alcune nuove macchine furono messe a
disposizione dell’amministrazione pubblica. Un’evoluzione significativa
del velocipede fu senz’altro nel 1818 la draisienne, uno spartano
apparecchio in legno con sella e rozzo manubrio collegato alla ruota
anteriore mobile per concedere libertà di direzione. L’invenzione del
barone tedesco Drais de Sauerbron fu promossa nelle principali capitali
europee ma ottenne notorietà più per le numerose vignette satiriche
della stampa che per l’effettiva diffusione del mezzo. Nella febbre
velocipedistica dell’età romantica non poteva mancare l’apporto della
genialità inglese con il pedestrian hobby-horse, velocipede interamente
metallico, che attrasse l’attenzione anche di alcune amazzoni londinesi
nel 1819. |
|
Velocimano.
|

The Velocipide, colour lithograph by Currier and James M. Ives, 1869.
© Museum of the New York/Corbis.
|
Alfredo Oriani con la sua bicicletta.
|
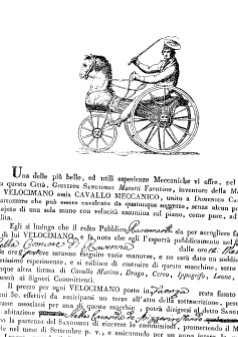
Il manifesto con cui Giuseppe Sangiorgi annuncia l'invenzione del Velocimano.
|
Nello
stesso anno anche in Italia si pubblicizzano le invenzioni
contemporanee del cavallo meccanico a tre ruote o velocimano, di due
valenti artigiani, il milanese Gaetano Brianza e pochi mesi dopo il
faentino Giuseppe Sangiorgi, detto Marèt. Il primo promuoverà la
sottoscrizione dei primi cento veicoli, al costo di 300 lire ciascuno,
con una poesia in dialetto milanese che decanta i pregi del Gran Cavall
Meccanegh:
……..
‹‹El se ciama in bon talian/ El Cavall Velocimann, / Perché coi mann
tocchee en ordegn/ Ch’el corr anc ben ch’el sia de legn; / Podii sta
comed sulla sella/ Mei del cavall del sur Ghinella, / Podii andà drizz,
podii sterzà/ Montà sull’alt, e reculà, / Se tant al mont che alla
pianura/ Podii viaggià senza pagura/ E fa per ben cent mia de strada/
Senza fal bev, ne dagh la biada./…››. Per pubblicizzare la nuova
macchina l’inventore faentino sceglie invece la piazza ravennate, sede
di legazione, alla quale si rivolge il costruttore con un manifesto che
recita:
velocimano
‹‹Una delle più belle, ed utili esperienze meccaniche vi offre Giuseppe
Sangiorgi Maretti Faentino, inventore della Macchina detta il
Velocimano ossia Cavallo Meccanico, unito a Domenico Casalini valente
carrozzaro, che può essere cavalcato da qualunque soggetto, senza alcun
pericolo, e con l’ajuto di una sola mano con velocità cammina sul
piano, come pure ad una discreta salita››. Con questo arcaico annuncio
pubblicitario rivolto ai cittadini ravennati nel maggio 1819,
l’ideatore faentino intendeva promuovere efficacemente con
un’esibizione nella sala comunale il nuovo veicolo a tre ruote, mosso
da leve e ingranaggi celati in un busto di cavallo equipaggiato di
briglie per orientare il movimento del mezzo di trasporto. L’abile e
intraprendente falegname faentino aveva allestito questo prototipo con
la foggia familiare del cavallo, ma si riprometteva di costruire altre
macchine con draghi, cavalli marini, cervi, ippogrifi, leoni o
qualunque altra foggia gradita agli acquirenti. Il prezzo fissato per
il velocimano costruito a Faenza era di scudi romani 30 e si assicurava
la manutenzione per un anno in caso di difetti meccanici.
|
Giuseppe Sangiorgi era nato a Faenza nel 1757, viveva in città nel
corso di Porta Ponte, attuale Corso Saffi, con due figli maschi, Carlo
e Pasquale, anch’essi falegnami provetti che prolungarono l’arte della
famiglia fin dopo l’unità d’Italia. Secondo la testimonianza
dell’architetto E. Golfieri, il soprannome di Marèt era stato
attribuito al nonno Francesco, ‹‹uno dei falegnami e carpentieri più
provetti di Faenza›› nella seconda metà del Settecento. Giuseppe,
‹‹prima sotto la guida di Giuseppe Boschi detto il Carloncino, poi
seguendo i modelli di G. Pistocchi col quale era in buoni rapporti,
divenne pratico anche di architettura. Ideò e costruì varie macchine
per cerimonie e feste pubbliche oltre a catafalchi per celebrazioni
funebri, ma anche modelli in legno per edifici e costruzioni di uso
pubblico da lui progettate››, oltre a produrre mobili per l’arredamento.
Forse le gare automobilistiche delle fantasiose “macchine a pedali”
V.a.p., ideate e costruite insieme dagli alunni e dagli insegnanti di
vari istituti romagnoli e stranieri, che si disputano da vari anni
nella città manfreda, sembrano realizzare ingenuamente ma in forme più
efficaci, grazie al contributo determinante dei pedali, della catena e
della moltiplica, quei lontani sogni romantici della velocità pura.
|
La bicicletta di Leonardo da Vinci
Fonte: “Il cicloturismo e la sua storia” (2005)
Nel Codice Atlantico (foglio 133v) di Leonardo da Vinci si trova il
disegno di una bicicletta eseguito con matita a carboncino e databile
intorno al 1493 che stupisce per la genialità della propria concezione,
e può considerarsi il progenitore della bicicletta moderna. Esso è
concepito in legno ed è provvisto di un sostegno fisso per appoggiare
le mani, di una forcella anteriore e posteriore, di un telaio
orizzontale che collega due ruote di uguale dimensione dotate di mozzi
e di raggi, di un asse (movimento) centrale, di una guarnitura (corona,
pedivelle e pedali) posta al centro del telaio, la quale a sua volta è
provvista di una catena di trasmissione che la collega a un pignone sul
mozzo della ruota posteriore motrice, di una sella con sospensioni ecc…
In altre parole, questo schizzo racchiude le invenzioni meccaniche più
importanti che si affermeranno laboriosamente solo tre-quattrocento
anni più tardi.
Le vicende legate al disegno di Leonardo e al suo ritrovamento hanno
del romanzesco, e forse proprio per questo hanno dato spunto alla
narrativa. Formato alla fine del XVI secolo dallo scultore Pompeo
Leoni, che riunì in un solo album circa 1300 carte vinciane, il Codice
Atlantico fu affidato dal 1966 al 1969 ai monaci del Laboratorio di
Restauro di Grottaferrata per un ripristino. Nel corso dei lavori i
restauratori staccarono due fogli piegati a metà e incollati fra loro
dal Leoni per coprire alcuni disegni osceni che vi comparivano. Il
primo ad accorgersi che accanto alle oscenità era visibile lo schizzo
di un veicolo molto simile a una bicicletta, fu nel 1972 il professor
Augusto Marinoni, il quale aveva ricevuto l’incarico di trascrivere il
codice dalla Commissione Vinciana di Roma. Marinoni annunciò la
scoperta due anni più tardi nel volume “The Unknown Leonardo“,
attribuendo lo schizzo non già alla mano del Maestro, bensì a quella di
un allievo della sua bottega, forse tale Gian Giacomo Caprotti, detto
Salaì, che avrebbe copiato “in modo puerile” un disegno poi perduto di
Leonardo.
La notizia del ritrovamento procurò molte critiche a Marinoni che da
alcuni studiosi fu addirittura ritenuto l’autore di un falso clamoroso.
In particolare, Hans-Erhard Lessing, al tempo curatore del
“Landesmuseum für Technik und Arbeit” di Mannheim, si scagliò contro di
lui respingendo con decisione l’autenticità dello schizzo. Tutte le
prove addotte dallo studioso tedesco si rivelarono però infondate. A
sostegno di Marinoni, al tempo considerato il massimo esperto a livello
mondiale di Leonardo da Vinci, si schierarono tra gli altri il
professor Jean-Pierre Baud dell’Università di Strasburgo e James McGurn
dell’Università di York.
Al momento attuale, si tende per lo più a negare a Leonardo la
paternità della bicicletta. Per spiegare l’intera vicenda, molti
divulgatori ricorrono ancora oggi all’ipotesi della burla escogitata da
un ciarlatano. Tenuto conto del fatto che, fino a questo momento,
nessuno ha potuto dimostrare che il foglio 133v del Codice Atlantico è
stato effettivamente manomesso in epoca recente, l’ipotesi della burla
convince, in tutta evidenza, men che poco. Al grande Toscano spetta
dunque il merito, fino a prova contraria, di avere concepito per primo
una macchina destinata a rivoluzionare le abitudini di vita dell’uomo
moderno. Checché se ne dica, tanta e tale ideale paternità della
bicicletta può solo accrescere il fascino di una straordinaria
invenzione.
La catena ideata da Leonardo da Vinci
Codice di Madrid I – Foglio 10r.
|
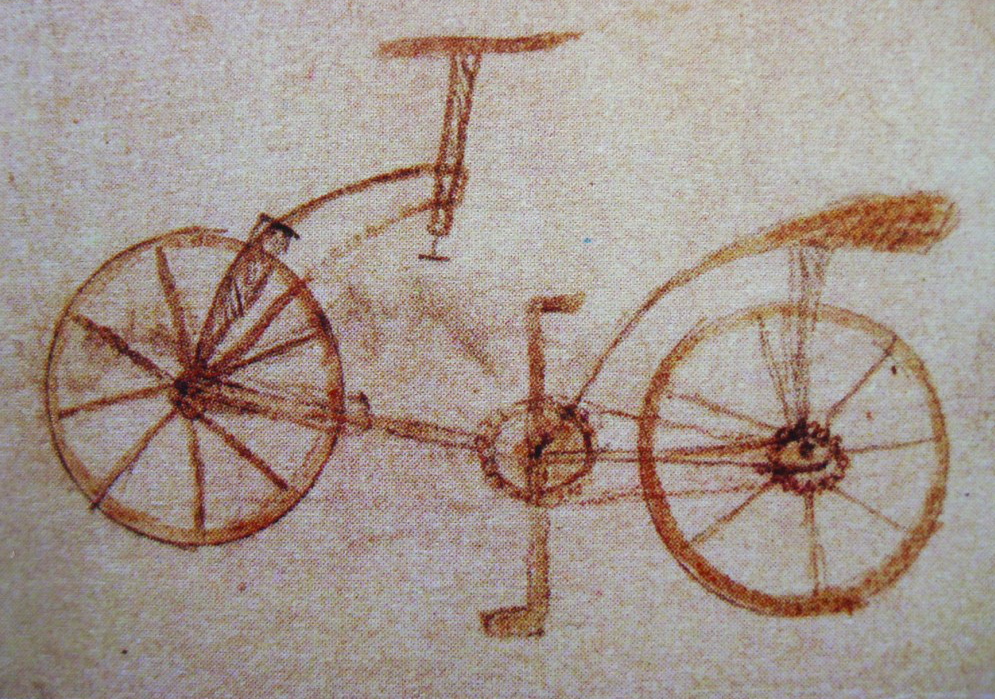
Bicicletta fornita di pedali e catena, disegnata
da Leonardo Da Vinci nel 1400.
(Codice Atlantico – foglio 133v.)
|

Celerifero 1721.
|
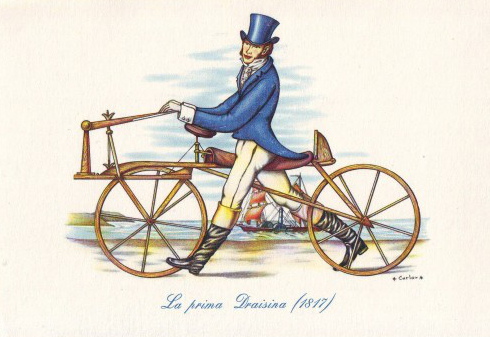
Celerifero 1721.
|
Ecco come e perche' in cento anni si
e' passati da celerifero a bicicletta
Fonte: Gazzetta dello Sport - Articolo pubblicato nell'edizione del 20 marzo 1998.
Prima di diventare bicicletta, la bicicletta era il
celerifero (dal latino, significa trasporto veloce). Anno 1790: il
conte francese Mede de Sivrac progettò due ruote di legno a sei raggi,
una trave unita alle ruote da due forche di legno, con cui si procedeva
a spinta, senza poter curvare. Da celerifero a velocifero ci sono
voluti 14 anni: anno 1804, a Parigi, nel Thèatre de Vaudeville, si
rappresentò Les velociferes, operetta ispirata all'invenzione del
conte. Il singolare marchingegno (che aveva origini più remote:
Leonardo da Vinci, anche) fu perfezionato da un altro nobile,
collezionista di nomi, Karl Friederich Christian Ludwig Drais von
Sauerbroun, barone, che lo mise a punto nel 1816 e lo presentò a
Parigi il 5 aprile 1818. Venne battezzato draisienne (in francese) e
draisina (in italiano). In Inghilterra non lo presero sul serio,
divenne hobby - horse e fu trasformato in un giocattolo per bambini. In
Italia lo presero troppo sul serio, divenne velocipede, fu bloccato da
un'ordinanza il 3 settembre 1818 e permesso dai ghisa soltanto sui
bastioni e nelle piazze lontane dall'abitato. Troppo pericoloso -
sostenevano - per i pedoni. Non, evidentemente, per i velocipedisti. Lo
stesso anno, 1818, era il cavall meccanegh, cavallo meccanico, del
milanese Brianza, spinto a forza di braccia. Un anno dopo, 1819, era il
velocimano, costruzione meccanica di Sangiorgi e Casalini [di Faenza], anch'esso
spinto a forza di braccia. Poi fu un inseguimento tra inventori, una
volata fra costruttori, uno spunto per artisti. Fino ad arrivare al
1884, quando nacque il bicicletto (al maschile): il torinese Costantino
Vianzone lo fabbricò con telaio e forcelle in legno, ruote in corda.
Finalmente nel 1888 è la bicicletta (al femminile): dal francese
byciclette (e non dall'inglese bicycle, che è neutro, e si legge
"baisicol"), composto da bi (dal latino bis, due) e cycle (dal greco
kyklos, che si legge "cuclos" e significa ruota).
Pastonesi Marco

|
|
|

