|
L'ATTENTATO A RIVAROLA
Angelo Emiliani
Nè col veleno nè con un colpo di pistola: i carbonari ravennati non
riuscirono a uccidere il cardinale Agostino Rivarola. Se erano giunti a
una determinazione simile, il solco che divideva l'alto prelato e i
cospiratori - allora venivano definiti «settarj», oggi «patrioti» -
doveva essere davvero profondo. Si vuole che la prima loggia massonica
di Ravenna sia stata «La Pigneta» sorta nel 1806 in pieno clima
napoleonico. Gli anni che seguirono la Restaurazione videro la nascita
di numerose altre società segrete fra le quali la Carboneria, diffusa
soprattutto in Romagna per opera del forlivese Piero Maroncelli, e in
Lombardia. A Ravenna si contavano tre sezioni: «la Protettrice» perché
influente e in grado di esercitare un controllo sulle altre, «la
Speranza» formata da studenti e «la Turba» nella quale confluivano
artigiani e operai, gente più disposta all'azione. Il carattere
antiaustriaco e anticlericale della Carboneria, assieme ai fatti di
sangue dovuti alla sua attività, costituiva motivo di forte
inquietudine a Roma: si temeva che l'Austria, prendendo a pretesto
questo stato di cose ai confini del Lombardo-Veneto, varcasse il Po per
imporre il proprio ordine. Tanto che il segretario di Stato della Santa
Sede, cardinale Ercole Consalvi, ordinò nel 1821 al cardinale Antonio
Rusconi, a capo della Legazione di Ravenna, di sbarazzarsi dei
personaggi più pericolosi confinandoli o mettendoli comunque in
condizioni di non nuocere.

|
 |
 |
Cardinale Antonio Rusconi (1743-1825)
|
Cardinale Ercole Consalvi (1757-1824) segretario di Stato di Pio VII
dal 1800 al 1806 e dal 1814 al 1823. |
Cardinale Agostino Rivarola (1758-1842). |
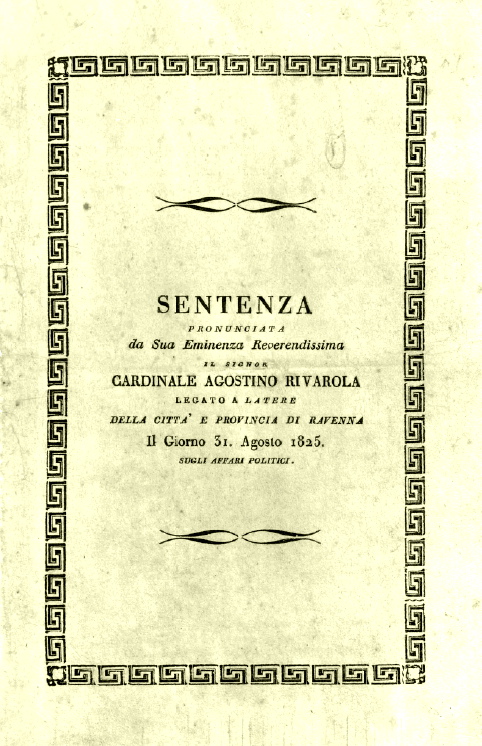
|
Gli arresti in massa dei mesi seguenti non risolsero il problema.
L'uccisione del conte Domenico Matteucci direttore provinciale di
polizia, avvenuta il 5 aprile 1824, indusse i vertici dello Stato
Pontificio a inviare nelle Quattro Legazioni (Bologna, Ferrara, Ravenna
e Forlì) uno degli uomini più energici, il cardinale Agostino Rivarola,
nominato Legato a latere con ampi poteri. Indagini a tappeto e un
deciso giro di vite - la prima misura di polizia adottata fu
l'istituzione della cassetta delle denunce - portarono al processo
conclusosi con la sentenza del 31 agosto 1825 a carico di oltre 500
persone, soprattutto ravennati e faentini, appartenenti a tutti gli
strati sociali. Furono comminate sette condanne alla pena capitale (poi commutate in
prigionia perpetua), 13 ai lavori forzati a vita, sei alla prigionia
perpetua, 94 ai lavori forzati e alla reclusione per varia durata e 386
al «precetto politico», ovvero ad un regime di sorveglianza
particolarmente vessatorio.
Concluso il processo, il cardinale Rivarola
avviò un tentativo di pacificazione fra carbonari e sostenitori del
potere temporale (e di quel periodo «il matrimonio dello Stradone» a
Faenza fra giovani e ragazze appartenenti alle opposte fazioni), mise
mano ad innovazioni in campo amministrativo e intensificò l'opera dei
frati predicatori contro il liberalismo e le idee rivoluzionarie.
Tuttavia l’eccesivo rigore e l'insensibilità verso i fermenti che
agitavano la Romagna gli valsero la reputazione di reazionario e
l'avversione senza appello dei carbonari. L'attentato maturò in questo quadro. |

L'attentato al Cardinale Agostino Rivarola in
un'illustrazione di Edoardo Matania.
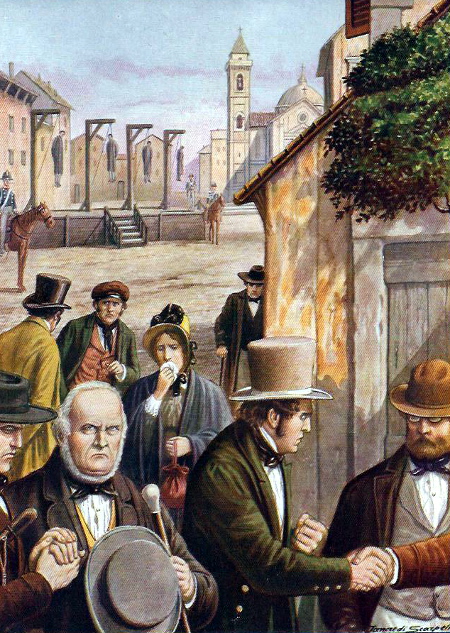
I patrioti Ortolani, Zanoli, Montanari e Rambelli giustiziati in
Ravenna il 13 maggio 1828 e tenuti appesi alle forche una intera
giornata, illustrazione tratta da: Paolo Giudici, Storia d'Italia
, vol. IV, edizioni Nerbini 1932.
|
La sera del 23 luglio 1826 un gruppetto di cospiratori attese a lungo
il cardinale nei pressi di palazzo Rasponi dove si era recato per un
colloquio con la signora Amata Spinelli consorte del conte Gabriele. Lo
videro infine uscire dal portone attorniato da alcuni servitori che
reggevano fiaccole accese e salire in carrozza in compagnia del
canonico Ignazio Muti. Fu allora che uno - probabilmente Angiolo
Ortolani «ministro del forno pubblico», lo stesso che aveva già tentato
di uccidere il Rivarola avvelenando il pane a lui destinato - si
avvicinò deciso, afferrò lo sportello e sparò un colpo di pistola che
finì però per colpire il canonico. «Rivarola - scrisse un secolo dopo
la "Rassegna storica del Risorgimento" riportando le parole di Domenico
Antonio Farini, a sua volta assassinato nel 1834 "per odio politico" -
parve non si dimostrasse punto alterato. Andò a cena e cenò, andò a
letto e dormì». Tuttavia fin dai giorni seguenti ritenne più salutare
stabilirsi dapprima a Faenza, poi a Forlì da dove scrisse al fratello
per rassicurarlo sulle sue condizioni, aggiungendo di essere
«tranquillo di spirito» e sorpreso per l'accaduto.
Fu il Governo pontificio a richiamarlo a Roma, inviando al suo posto
una commissione di giudici incaricata di rintracciare i responsabili e
punirli. Presieduta da monsignor Filippo Invernizzi, arrivato con una
scorta di 180 uomini armati 60 dei quali a cavallo, e dal colonnello
dei carabinieri Giacinto Ruvinetti, conosciuto a Ravenna per i metodi
brutali e autoritari, la commissione non andò tanto per il sottile
quanto ai metodi adottati. Delazioni, carcerazioni arbitrarie e sevizie
resero ancora più largo il fossato con buona parte della popolazione.
L'inchiesta si concluse due anni dopo con la condanna «all'estremo
supplizio» di cinque persone, pronunciata a Faenza il 9 maggio: oltre
ad Angiolo Ortolani, furono affidati al boia - il tristemente celebre
«mastro Titta», ovvero Giovanni Battista Bugatti - il calzolaio e
possidente Luigi Zanoli, il barbiere Gaetano Montanari, il cappellaio
Gaetano Rambelli coinvolto nell'assassinio del conte Matteucci e
l'ebreo lughese Abramo Isacco Forti soprannominato Marchino per
complicità nella morte del fratello Mosè. Furono impiccati il 13 maggio
1828 in piazza degli Svizzeri, l'attuale piazza Garibaldi, e i loro
corpi restarono esposti quale macabro ammonimento fino al giorno dopo
in una città sgomenta e deserta.
 Ravenna, Piazza Maggiore (ora Piazza del Popolo) in una incisione di fine '800.
Ravenna, Piazza Maggiore (ora Piazza del Popolo) in una incisione di fine '800.
|
|

