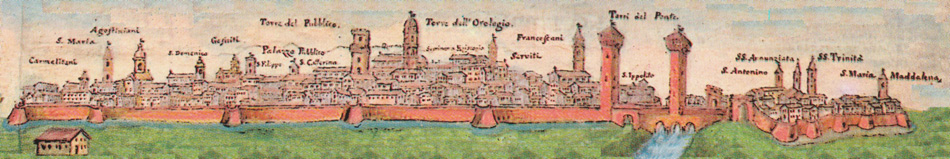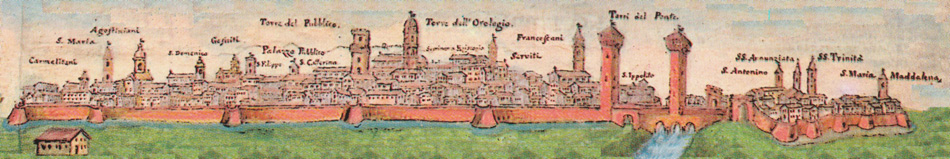|
Leonardo da Vinci in Val di Lamona
Gian Paolo Costa
La
presente epoca del pontificato Bergoglio pare lontana molti anni luce -
non solo secoli (e non moltissimi!) - dai tempi dei Papi sovrani.
Il 26 agosto 1492, ventritrè giorni dopo la partenza di Cristoforo
Colombo per l'America (dove il genovese sbarcherà, il 12 ottobre), lo
spagnolo Rodrigo Borgia viene incoronato Papa-Principe della
Chiesa: Alessandro VI , 214°
Papa. Era padre di sette figli, tra i quali passeranno alla Storia il
primogenito Cesare (noto come "il Valentino", in quanto cardinale di
Valencia e duca di Valentinois) e la figlia Lucrezia.
Alessandro VI
conduceva una vita da vero... sovrano laico e per questo venne
duramente attaccato dal Domenicano Girolamo Savonarola, nativo di
Ferrara, che fece la fine che sappiamo: impiccato e poi bruciato; le
sue ceneri, assieme a quelle di fra Domenico e fra Silvestro impiccati
prima di lui, furono sparse in Arno. Il papa assecondò le ambizioni sfrenate di Cesare, che ambiva a un
proprio ducato e aveva posto gli occhi sul Montefeltro e la Romagna. Il
Valentino fu messo in grado di eliminare con estrema ferocia le
signorie dei Montefeltro a Urbino, dei Malatesta a Rimini, di Caterina
Sforza a Forlì e Imola, e dei Manfredi a Faenza. Caduta Faenza
nell'aprile del 1501, Astorre Manfredi e il fratellastro Giovanni
Evangelista (coetaneo perché figlio di Cassandra Pavoni) furono chiusi
in Castel Sant'Angelo: saranno strangolati e gettati nel Tevere l'anno
successivo, insieme ai loro "maestri di camera". Astorre/Astorgio, del
quale si tramanda l'avvenenza, era allora poco più che diciassettenne.
Dall'età di tre anni, ovvero dall'assassinio del padre Galeotto per
volere della consorte Francesca Bentivoglio, che non perdonava il
rapporto del marito con l'amante Cassandra Pavoni che proseguiva nel
convento di San Maglorio, Astorre veniva allevato e cresciuto in
Faenza, da istitutori, perché i faentini desideravano succedesse al
padre.
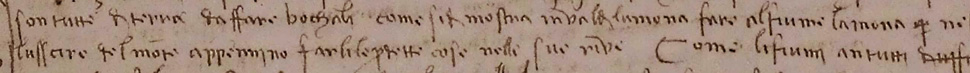
|
"...son
tutte di terra da fare boccali come si dimostra, in Val di Lamona, fare
al fiume Lamona (q) nell'uscire del Monte Appennino far le
predette cose nelle sue rive".

Boccale con stemma dei Manfredi.
Signori di Faenza. Maiolica,
fine sec. XIV - inizio sec. XV.
|
Una volta costituito il proprio ducato - che peraltro ebbe vita molto
breve anche per la morte del Padre-Papa per un attacco di malaria. Il
18 agosto 1503 - il Valentino si rivolse all'ingegnere/architetto
militare allora più "gettonato" per ammordernare le strutture
difensive: Leonardo da Vinci. Tra l'agosto (un mese che si ripropone,
in questa vicenda!) e il dicembre 1502, Leonardo visita le città
Romagnole, militarmente importanti, lungo la via Emilia, sotto il
diretto controllo del Valentino. Si muove liberamente grazie al
lasciapassare rilasciatogli (pervenuto ai giorni nostri) e appunta le sue osservazioni sul taccuino L.,
ora a Parigi dopo il passaggio per la penisola di Napoleone (!).
È a
Rimini, a Cesena, a Cesenatico (dove disegna il porto canale e ne
esegue una splendida immagine prospettica dall'alto), passa per Faenza
e, infine sosta a lungo, alcuni mesi, sino a dicembre, a Imola: città
quest'ultima "di confine" e da lui - e probabilmente dal suo "datore di
lavoro" - giudicata militarmente più importante. Qui, tra l'altro,
esegue la splendida, e per concezione modernissima, mappa di Imola oggi
nel fondo Windsor della Regina d'Inghilterra. Di e su Faenza, Leonardo
ci lascia - molto probabilmente, ma considerando il contesto potremmo
dire sicuramente - un'immagine del Duomo, non ancora ultimato, e alcuni
appunti che fanno riferimento diretto alla geologia locale
appenninica e all'artigianato ceramico. Nel codice Hammer (1504-1506) accenna alla presenza in val di Lamona di terra da fare boccali,
boccali che si fabbricano sulle rive del fiume medesimo, ovviamente a
Faenza! Per poi aggiungere: "...dove per antico li monti Appennini
versavano li lor fiumi nel mare Adriano, li quali in gran parte
mostrano in fra li monti gran somma di nichi [conghiglie fossili]
insieme coll'azzurrigno terren di mare...". Alla luce di queste e altre
veloci notazioni geologiche "romagnole", non è escluso che Leonardo a
Faenza abbia risalito un tratto della val Lamone in direzione di
Firenze (o, vedi mai, che l'abbia percorsa in occasione di un suo
trasferimento Firenze-Romagna). |
Dal libro: "Il lasciapassare di
Cesare Borgia a Vaprio d'Adda
e il viaggio di Leonardo in Romagna"
testi di Sandra Faini - Lorella Grossi
|
I SUOLI DI ROMAGNA
Le
annotazioni di ordine geologico attinenti alla Romagna sono
prevallentemente contenute nel codice Hammer, l'unico manoscritto cui
Leonardo abbia cercato di dare una forma organica. La datazione del
manoscritto non è sicura: tuttavia la maggioranza degli studiosi
collocano la sua compilazione tra il 1505 e il 1508 e Calvi lo destina
in epoca immediatamente successiva al viaggio leonardiano in Romagna.
Le annotazioni geologiche che riguardano quest'ultima, fissate ai fogli
9 recto, 10 recto e 36 recto, evidenziano, da un lato, il profondo
grado di conoscenza del terreno raggiunto da Leonardo, possibile solo
all'indomani di una lunga permanenza in Romagna, dall'altra possiedono
anche il sapore di ricordi personali. Così nel foglio 9 recto Leonardo
dimostra di conoscere perfettamente la causa della presenza di "nichi",
vale a dire di fossili marini, sui monti dell'Appennino e
contemporaneamente da una poetica definizione delle argille azzurre,
definendole "azzurrigno terren di mare".
|
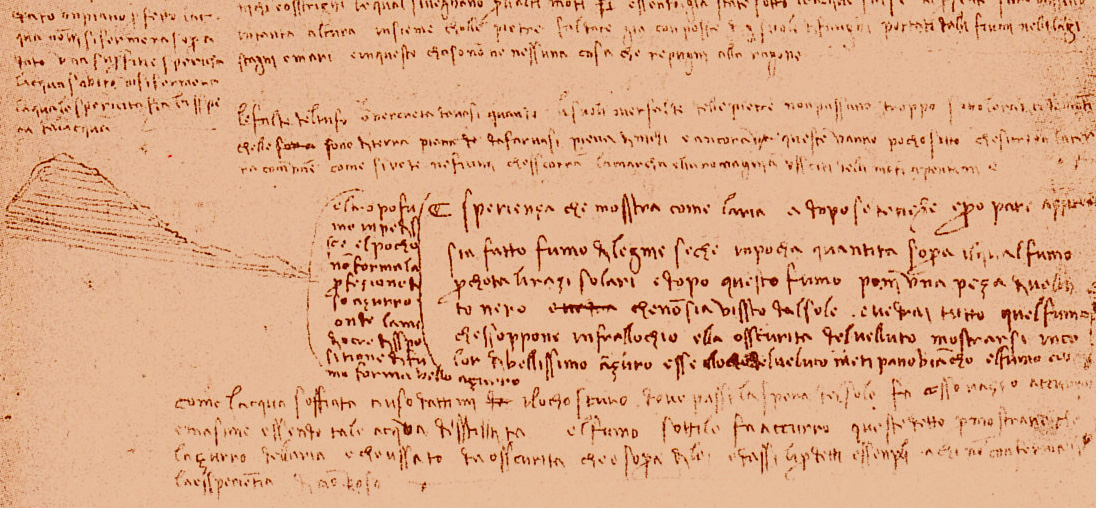
Particolare della pagina 36 recto del Codice Hammer, appunti con disegno, 30 x 22 cm.
(Le falde del tufo, o ver creta da vasi, quando) Li suoli, o ver
falde delle pietre, non passano troppo sotto le radici de' monti,
ch'elle (son a) sono di terra (piena da) da far vasi, piena di nichi; e
ancora (va) queste vanno poco sotto, che si trova la terra comune, come
si vede ne' fiumi, che scorran la Marca e la Romagna, usciti delli
minti Appennini, e...
|
| Un
altro riferimento alla
Romagna è presente nel brano successive, il 10 recto, in cui è
ricordato il paesaggio argilloso, percorso da calanchi, caratteristico
della Val Lamone e si accenna alla produzione faentina di ceramiche o,
per meglio dire, di "boccali". Infine, se si confronta il brano 36
recto con i precedenti, ci si
avvede di come Leonardo possedesse già il concetto di stratigrafia e
potesse riconoscere bene tre unità rocciose: le formazioni Marnoso -
arenacee e Gessoso - solfifere, le argille azzurre e le terre
alluvionali pedemontane, che egli nomina, rispettivamente, "falde dalle
pietre vive", "azzurrigno terren di mare" e "terra comune". Accanto al
brano finale 36 recto, a corredo visivo dell'annotazione, Leonardo
traccia uno schizzo stratigrafico. |
|
Dal libro:
"Geositi testimonianze del tempo"
a cura di Giancarlo Poli
|

|
Leonardo cita espressamente la Valle del Lamone descrivendone le rocce: "le
radici settentrionali di qualunque alpe non sono ancora petrificate; e
questo si vede manifestamente dove i fiumi, che le tagliano, corrano
inverso settentrione, li quali taglian, corrano inverso settentrione,
li quali taglian nell'altezza de' monti le falde delle pietre vive, e
nel congiungersi colle pianure, le predette falde son tutte di terra da
fare boccali, come si dimostrano, in Val Lamona, fare al fiume Lamona
nell'uscire del monte Appennino, far lì le predette cose sulle
sue rive". [codice Gates ex Leicester, ex Hammer 10A, 10r].
Non
si limitò a questi commenti: negli stessi anni, mentre completava la
grande tavola di "Sant'Anna, la Madonna e il Bambino con l'agnello",
esposta ora nella Grande Galerie al Louvre, vi illustra, nel Basamento
su cui poggiano i piedi del mirabile gruppo, un particolare degli
strati arenacei e marmorei di questa formazione, scandendo fino nei più
minimi dettagli le lamine ondulate, di spessore inferiore al mm, simili
a quelle formate da una corrente su un fondale sabbioso marino.

|
A sinistra, S. Anna, la Madonna e il Bambino con l'agnello, esposto nella Grande Galerie del Louvre, Parigi. Sopra,
particolare. Finissime lamine ondulate (increspaturebdi fondo e piccole
dune, che si formano sui fondali sabbiosi marini e sulla sabbia dei
deserti), isegnate nello strato marron su cui poggia il piede della
Vergine. Al di sotto si distingue uno strato grigio omogeneo. Questa
alternanza marron-grigio (arenaria-marna) ripetuta per migliaia di
volte caratterizza la formazione marnoso-arenacea nell'Appennino
romagnolo e umbro. A sinistra in basso firma di Leonardo da Vinci.
|
|
|
SANT’ANNA, LA MADONNA E IL BAMBINO CON L’AGNELLO (1510 circa)
Leonardo da Vinci (1452-1519) Museo del Louvre – Parigi. Olio su tavola cm. 168 x 130
Il dipinto rappresenta sicuramente uno dei vertici dell’arte di
Leonardo e di tutta la pittura del Rinascimento. La composizione è
basata sul groviglio costituito dalle tre figure, Sant’Anna, la Vergine
e il Bambino, che formano una sorta di struttura a piramide, un’idea
che avrà larga fortuna fra gli artisti contemporanei: si vedano, ad
esempio, certi dipinti di Raffaello o di Andrea del Sarto. La Madonna,
seduta in grembo alla madre, si piega violentemente in avanti per
staccare il piccolo Gesù dall’agnellino (animale immolatile) al quale
si era avvinghiato. Il tenero animale rappresenta notoriamente il
simbolo della Passione di Cristo; la scena simboleggia dunque la
consapevolezza di Gesù nell’andare incontro al suo destino. La Vergine
vuole trattenere il figlio per impedire che questo destino si
compia. Ma Sant’Anna, che simboleggia la madre Chiesa, trattiene
a sua volta la Vergine poiché desidera che si avveri il sacrificio di
Cristo per l’umanità. Nonostante la compattezza della struttura
piramidale il gruppo delle tre figure e dell’animaletto è
caratterizzato da un forte dinamismo.
La
Vergine che si protende fortemente verso destra allungando gli arti
conferisce un movimento rotatorio a tutta l’immagine. Anche il
paesaggio nello sfondo, con le montagne aguzze avvolte nelle brume, i
corsi d’acqua in lontananza, le rocce che sembrano sprofondare sotto i
piedi delle donne nel primo piano contribuiscono a creare un effetto di
inabilità e di continua oscillazione. Siamo negli anni 1510-1513,
periodo durante il quale Leonardo era interessato alla rappresentazione
del movimento delle figure nello spazio atmosferico.
Il quadro si
trovava nel 1517 nello studio di Leonardo presso il castello di Cloux
(oggi Clos-Lucé) nei pressi di Amboise. Fu successivamente riportato in
Italia da Francesco Melzi, il più fedele allievo dell’artista, insieme
a molti altri dipinti, disegni e manoscritti appartenenti all’eredità
leonardesca. Dopo un periodo di oblio il quadro fu ritrovato e
riconosciuto nel 1629 a Casale Monferrato dal Cardinale Richelieu, che
lo donò nel 1636 a Luigi XIII. Dalle Collezioni reali francesi è quindi
passato al Louvre.
|
|
La storia del Codice Leicester - Hammer ora Gates
Il Codice Leicester (1505-1510) è uno dei quaderni di appunti
composto da Leonardo Da Vinci nel quale l’autore ha trascritto le sue
osservazioni ed i suoi studi, supportandoli con disegni. Il manoscritto
è costituito da 18 carte doppie, cioè 36 fogli (dimensioni: cm 27 x 20)
con recto e verso. Sono stati compilati riempiendo un foglio doppio
dietro l’altro ed inserendolo ogni volta nei precedenti. E’ esemplare
per conoscere il metodo di compilazione usato da Leonardo: è infatti
una raccolta di appunti non organizzati in modo sistematico e
definitivo e reintegrati via via con osservazioni, nuove considerazioni
ed esperimenti. Ci sono sottolineature, aggiunte, cancellature
improvvise che evidenziano l’immediatezza della composizione ed un
procedere per enunciati ed interrogativi.
Il tema principale è l’acqua con appunti e disegni di vortici e
correnti, osservazioni di idrostatica, idrodinamica ed ingegneria
idraulica, ma non mancano studi e riflessioni sull’illuminazione del
sole, della terra e della luna. Insieme alle intuizioni più originali,
come quella sul lumen cinereum della luna, dal codice emergono anche
gli errori che Leonardo ereditò dalla tradizione: per esempio riteneva
che le maree siano dovute al fatto che l’acqua viene “bevuta” dal fondo
del mare. Il tutto è composto con scrittura speculare a quella comune,
scrive infatti da destra verso sinistra; questo sembra sia dovuto ad
una questione ottica istintiva, assai frequente nei bambini, che in
Leonardo non viene corretta in giovane età, anche se molti hanno voluto
intravedervi più affascinanti intenti di segretezza.
Il manoscritto fu rinvenuto a Roma nel 1690 dal pittore Giuseppe Grezzi
in un vecchio baule. Grezzi tenne il manoscritto fino al 1717, quando
un inglese Thomas Coke di Leicester lo comprò.
Il Codice rimase nella sua casa fino a quando un uomo d’affari
americano, Armand Hammer, lo comprò nel 1980 nominandolo Hammer Code.
Nel 1994 Bill Gates, presidente della Microsoft, lo acquistò per 30 milioni di dollari, rinominandolo Leicester Code.
Da quando è stato acquistato da Gates il manoscritto è stato esposto
nei musei di Venezia, Milano, Roma, Parigi, New York ed ora è a
Seattle.
Dopo il suo giro, il Codice farà ritorno a Gates Museum, dove una
cripta opportunamente progettata e climatizzata lo ospiterà. Qui il
Codice nell’oscurità completa trascorrerà la maggior parte del suo
tempo quando Gates desidererà vederlo lo farà solo per brevi periodi ed
in condizioni di luce regolata.
(Fonte: http://www.omniarte.it/)
|
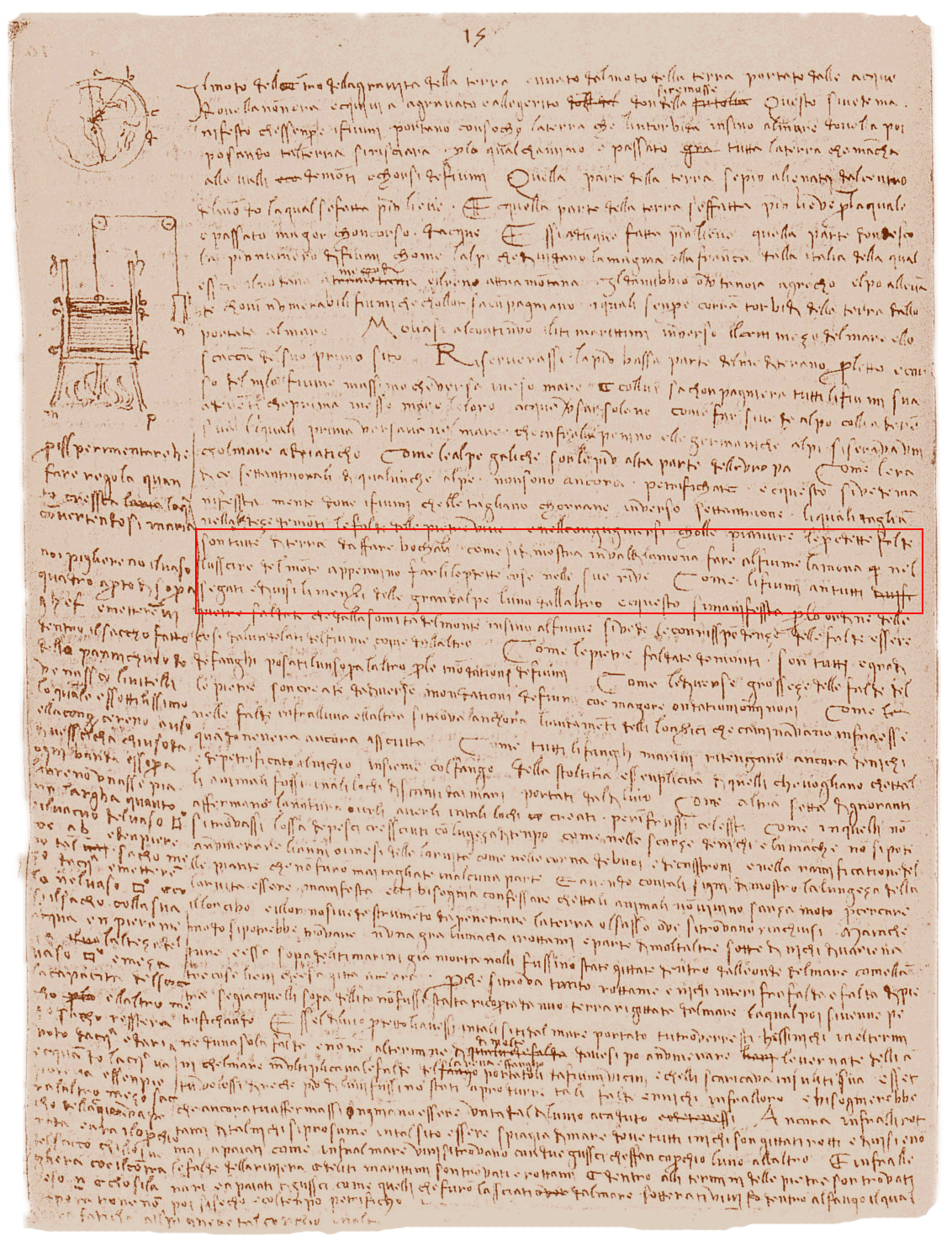
Codice Hammer, foglio 10 recto, 30 x 22 cm.
"Come le radici settentrionali di qualunche alpe non sono ancora
petrificate; e questo si vede manifesta mente dove i fiumi, che le
tagliano, corrono inverso settrantrione, li quali taglian nell'altezze
de' monti le falde delle pietre vive; e, nel congiungersi colle
pianure, le predette falde son tutte di terra da fare boccali, come si
dimostra, in Val di Lamona, fare al fiume Lamona (q) nell'uscire del
monte Appennino, far lì le predette cose nelle sue rive".
|
|